Giorgio Franchetti si interessa di storia romana da decenni. Per le Edizioni Efesto ha pubblicato il saggio storico “A Tavola con gli Antichi Romani”, (2017).
Lei ha definito la storia romana “un materasso culturale per il mondo intero”.
Ce ne spiega le ragioni?
Con piacere. È una questione, a mio avviso, sociologica. Anzi, guardi, diciamo meglio: di antropologia sociale. Roma arrivò a inglobare, sotto Traiano, un territorio vastissimo, popolato di genti che entrarono in contatto con gli occupanti e che, con loro, instaurarono un rapporto di osmosi culturale. Quando due o più popoli entrano in contatto è inevitabile una reciproca contaminazione, si prende e si dà, e questo avviene, negli individui, a vari livelli di coscienza: consapevolmente, e non. La contaminazione vera e propria, a mio parere, è quella a livello più profondo, quella inconsapevole, perché a livello di volontà si può operare una scelta che può decidere di escludere talune cose. Quando invece quelle cose sono percepite indirettamente si radicano più profondamente nell’animo proprio perché non si riesce ad arginarle. Un tempo, anche tra culture confinanti, esistevano divisioni più nette garantite da distanze maggiori tra centri abitati e dalla minore possibilità di interazione e comunicazione. Quindi poteva accadere che popoli anche vicini fossero molto diversi culturalmente. In questi incontri-scontri (perché a volte la cultura è stata “esportata” con la guerra) spesso esisteva uno squilibrio tra chi dava e chi riceveva novità. Quando Roma arrivò in Gallia con Cesare nel 58 a.C. trovò tribù divise, autonome, disorganizzate, culturalmente limitate nella loro espressione di civiltà organizzata, con evidente limite al processo di civilizzazione. Roma, invece, dopo sette secoli di storia, era a tutti gli effetti una civiltà, nel senso stretto del termine, che non va confuso con cultura. Per civiltà si intende un popolo che si è costituito e dato un ordinamento sociale, che si riconosce come un’unità per condivisione di vari fattori comuni, per la presenza, a mio avviso, di infrastrutture di beneficio pubblico e per un’organizzazione istituzionale. In Gallia c’era una grande cultura, ma non una grande civiltà. Roma, al contrario, fu da subito una monarchia costituzionale, come osservò Mommsen. In questo panorama storico, il divario tra due popoli così profondamente impari porta inevitabilmente, nel contatto, a uno squilibrio nello scambio di novità, informazioni, passaggio di concetti. È il più debole, o il meno organizzato e progredito, a ricevere il maggior beneficio dall’altro. D’altronde, il progresso corre sempre in un’unica direzione e, volontariamente, non inverte mai la rotta. Il concetto stesso di progresso prevede l’innalzamento di un fattore rispetto una condizione precedente. A questo va aggiunto che i Romani avevano l’abitudine di romanizzare i territori, applicando lì dove arrivavano e intendevano soffermarsi, i princìpi che adottavano in patria, e questo dicasi sia per la normativa (pur rispettando spesso la normativa locale alla quale la romana si sovrapponeva per giudizi di grado superiore), sia per quanto concerneva la costruzione di infrastrutture pubbliche. E questo avvenne non solo nei confronti di popoli divisi in tribù, come ad esempio in Gallia e in Britannia, ma anche nei confronti di popoli più organizzati e civilizzati. Non avvenne in Grecia, o quanto meno non in maniera così forte, perché esisteva già una fiorente civilizzazione che, al contrario, diede molto a Roma sotto il profilo culturale. Ma si tratta di un caso isolato. Per il resto, Roma impresse il proprio stile e il proprio modus vivendi e l’alta civilizzazione raggiunta si diffuse poi a livello mondiale. Il merito va agli autori classici. Da sempre considerati modello da tutti (lo stesso termine “classico” stabilisce un modello consolidato e spesso oggetto di imitazione), vennero continuamente ripresi nel corso dei secoli, da letterati e da giuristi. L’ordinamento giuridico romano, di eccellenza e all’avanguardia nel mondo antico, ancora oggi è alla base degli ordinamenti di tutto il pianeta. Quindi, finita l’epoca dei Cesari, il mondo romano sopravvive grazie alla cultura e alle leggi che ebbe Roma, nelle quali da sempre attingono artisti e giuristi di tutto il mondo. Ecco perché ritengo che la cultura di quel popolo rappresenti un materasso di spunti, ispirazioni e nozioni sul quale l’intero pianeta si adagia ancora oggi comodamente.
Usi, costumi e consuetudini d’un mondo davvero remoto.
Quali sono le difficoltà insite nel lavoro d’un divulgatore storico?
Nel mio caso, principalmente, la scelta del linguaggio da adottare. Quello che cerco di fare è avvicinare il grande pubblico alla storia, all’archeologia e alla storia dell’arte. Tutte bellezze e ricchezze di questa nostra incredibile Italia. Quando operi una scelta di questo genere devi necessariamente trovare il modo di parlare la lingua di tutti. Ti ritrovi a raccontare situazioni, processi sociali, avvenimenti storici che spesso hanno alle spalle intricate ragioni economiche e politiche e devi farlo in maniera semplice, lineare, in modo tale non solo da trasmettere a chi ascolta, o legge i tuoi libri, quei concetti, ma soprattutto far sì che li possa comprendere a fondo. Perché altrimenti non c’è comunicazione, ma solo un polo trasmittente senza un polo ricevente. Durante le presentazioni dei miei libri, o durante le conferenze, io passeggio sempre tra il pubblico, non sto mai seduto dietro una scrivania con un pc davanti e uno schermo dietro. Per due motivi. Il primo è che amo stare tra la gente, guardare le persone negli occhi mentre parlo, a volte singolarmente, creando una sorta di rapporto quasi esclusivo, più personale, con chi viene ad ascoltarmi. Il secondo è che, come ricordo sempre a ogni inizio di conferenza, non sono io il protagonista della storia che il pubblico, quella sera, ha scelto di venire ad ascoltare, ma la Storia stessa. È lei la protagonista, la Storia con la S maiuscola. Pertanto il palco e il fulcro dell’attenzione deve essere solo per Lei e non per me, che invece me ne sto di lato o passeggiando tra la gente mentre proietto immagini sullo schermo. In questo modo, oltretutto, il pubblico si sente più partecipe, empatizza molto di più con il contesto, se ne sente parte, e sicuramente la percezione dell’esperienza, alla fine di tutto, sarà diversa da una normale conferenza. Poi, aggiungo, non mi piace proprio il divario, anche fisico, dello stare dietro una scrivania: crea uno “scalino” che qualcuno potrebbe percepire come “sociale” tra chi parla e chi ascolta, come se ci fosse un “posto” solo per chi parla e solo per chi ascolta al mondo e non deve essere così. Purtroppo a volte chi parla teme di “impoverire” i concetti che esprime se non infarcisce il proprio discorso di nozionismo tecnico. Parafrasando Carandini, è inutile parlare di “dendrocronologia” con persone non tecniche che ti vengono ad ascoltare, è più utile spiegare che esiste un metodo di datazione basato sull’accrescimento degli anelli degli alberi, poi se c’è tra il pubblico qualcuno che sa che si può dire con una sola parola tanto meglio per lui. I paroloni tecnici non aiutano in un ambito non tecnico, e creano invece spesso un divario incolmabile.
Lei svolge attività di ricerca sull’archeo-medicina.
Ebbene, su quali campi di applicazione pratica e teorica s’incentra?
L’archeo-medicina è la mia passione più profonda. Ho incrociato questa branca di studi, che si pone a cavallo tra la medicina e l’archeologia, durante gli anni della mia formazione e me ne sono innamorato. Effettivamente, è un argomento che esula da quelli più comuni, legati alle due materie, e per questo ancora pieno di lati oscuri e interessanti punti di approfondimento. La vita di questi personaggi, i medici antichi, era particolare: si trattava di un esercito di professionisti della salute assolutamente eterogeneo, in ogni campo. C’erano tra loro soprattutto Greci e Romani, ma alcuni provenivano dal vicino Oriente. Alcuni erano schiavi, poi quasi tutti vennero liberati. Altri generarono figli che seguirono le orme paterne e che operarono in totale libertà. Alcuni raggiunsero i gradi più alti, divenendo medici di imperatori e famiglie imperiali, guadagnando anche delle vere fortune, altri, al contrario, caddero così in disgrazia da dover fare “un secondo lavoro”, come il becchino, o peggio ancora, il gladiatore, come ci racconta Marziale. Insomma, c’è un vero e proprio mare di storie ed eventi umani dietro ognuno di questi medici e c’è tantissimo da scoprire e raccontare. Oggi l’archeo-medicina è prettamente vissuta in maniera teorica, con lezioni di storia della medicina nelle università, abbracciando soprattutto il periodo ellenistico greco-romano, e con alcune sortite in Egitto per discutere dei papiri medici. Nel mio caso specifico, però, ho cercato di andare oltre. Negli ultimi 24 anni ho iniziato a farmi realizzare, da esperti artigiani quasi tutti israeliani, delle perfette repliche di strumenti chirurgici presenti in vari musei del mondo, cui ho aggiunto quelli di cui non abbiamo reperti ma che sono perfettamente descritti dalle fonti storiche. Oggi possiedo riproduzioni di strumenti chirurgici egizi, greci e romani, e la mia collezione è stata definita dal prof. Ralph Jackson, il maggior esperto mondiale di medicina antica, come la più vasta e dettagliata al mondo. Questa collezione, che a volte viene ceduta in prestito ai musei per delle esposizioni tematiche (come nel caso del Museo di Storia della Medicina, nel 2019), è al centro degli interventi che ho fatto in alcune università, come Roma Tre, La Sapienza e l’Università di Salerno, durante alcune lectiones magistrales che ho tenuto sulla storia della medicina egizia e greco-romana. I giovani studenti di medicina hanno potuto così vedere da vicino una serie di immagini di reperti e di scheletri e prendere poi visione degli strumenti utilizzati nei casi specifici, oltre a poter toccare con mano tutta una serie di strumenti medici che si sono spesso rivelati estremamente simili a quelli tutt’ora in uso nelle moderne sale operatorie. Questa è la principale applicazione, oggi, di questa conoscenza e di questi strumenti, che ho avuto il piacere di esporre in due occasioni anche presso il Museo di Gerusalemme. Il trasporto di oggetti così particolari attraverso i sistemi di sicurezza aeroportuali di Tel Aviv è stato semplificato dall’intervento dell’Ufficio di Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma, che ringrazio. Naturalmente, oltre all’esposizione durante incontri e dibattiti, un’ultima possibilità di impiego è quella nel settore documentaristico. I miei strumenti sono stati al centro di una puntata di Lineaverde su Raiuno e sono stati segnalati dal prof. Jackson a The National Geographic Channel per un documentario sulla medicina sui campi da guerra nell’antichità, cosa, quest’ultima, di cui vado davvero molto fiero.
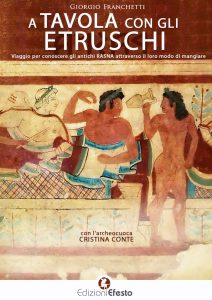 “A tavola con gli antichi romani” ed in uscita “A tavola con gli Etruschi”.
“A tavola con gli antichi romani” ed in uscita “A tavola con gli Etruschi”.
Esistevano le diete ipocaloriche tanto in voga oggidì?
Direi proprio di no, non almeno nel senso che intendiamo oggi. Non esisteva il concetto, in antichità. Chi era facoltoso, dimostrava la propria opulenza anche a tavola, specie nell’esibizione presso terzi ma, a differenza di quanto comunemente ritenuto, il ricco romano quando era solo con la propria famiglia, non mangiava nelle sale tricliniari, ma regolarmente seduto. Le sale tricliniari erano intese come una sorta di moderni uffici di rappresentanza, dove ricevere e intrattenersi con personaggi con cui si voleva tramare, fare affari, stringere accordi matrimoniali o anche solo per dimostrare la propria ricchezza e generosità. Il tutto affinché, il giorno seguente, gli invitati potessero tessere le lodi del proprio anfitrione. Marziale scriveva “non è sufficiente per te, Tucca, essere goloso: vuoi che così si dica di te, e così apparire…”. Caligola beveva perle disciolte nell’aceto e cibi cosparsi di polvere d’oro, dichiarando di dover scegliere tra l’essere frugale oppure un Cesare. Anche Adriano fece parlare di sé con il famoso tetrafarmaco, così come Gallieno che indugiava nei peccati di gola. Però, questo sì, esisteva un concetto molto presente presso i Romani, specie quelli di stampo catoniano, che vedeva nell’eccesso di cibo e in quanto circondava questi rituali culinari, un impoverimento pericolosissimo del pondus romano, un ammorbidimento e addirittura una corruzione dei costumi degli avi. Questi personaggi prediligevano (almeno così scrivevano) un’alimentazione più moderata, morigerata, parca. Seneca, ad esempio, invocava una parsimonia veterum che era presente agli albori della storia di Roma e citava la rapa come emblema di questa semplicità. Tra questi strenui conservatori troviamo anche degli imperatori, che facevano della frugalitas un dovere morale nel rispetto delle tradizioni degli antenati. E fra loro Augusto, che mangiava pochissimo e solo il necessario. Ma anche Plinio il Vecchio raccomandava di mangiare poco senza eccessi. Ecco, per loro fu una scelta, poi, certamente, la maggioranza del popolo viveva in povertà e digiunava, a volte, senza scegliere di farlo, o comunque aveva delle carenze a livello nutrizionale spesso evidenziate anche da altri aspetti. Anche qui l’archeo-medicina si incrocia con i dati demografici e sociali: l’ex voto più frequente è il seno, e questa usanza di ricorrere alla sfera religiosa nella cura delle malattie era prerogativa, quasi esclusiva, del ceto medio-basso, cioè quella popolazione che non poteva permettersi cure sofisticate da parte dei medici. Certamente la loro alimentazione era inadeguata e la massiccia presenza di seni dimostra che la lattazione era assente o ritenuta insufficiente.
Lei possiede all’attivo partecipazioni a documentari come “Ulisse” di Alberto Angela o trasmessi da History Channel e The National Geographic Channel.
Quali differenze o analogie potrebbe indicare circa il mezzo di divulgazione storico-archeologica?
Il mezzo televisivo è estremamente potente e persuasivo. Raggiunge moltissime persone usando linguaggi diretti, semplici e accompagnati da immagini. Tutto risulta semplice e di immediato apprendimento da parte del pubblico. Quindi ritengo i documentari uno strumento eccezionale di divulgazione e informazione. Personalmente ritengo che non ci si debba legare a un unico personaggio ma ai contenuti. Il rischio è quello di essere interessati più alla visione del presentatore che all’argomento trattato, e questo è un fenomeno sociologicamente accertato e concreto. Si riesce ad avere la capacità critica di scegliere i contenuti o, tutt’al più, di selezionare le informazioni che vengono veicolate? Non saprei. Quindi, è evidente, chi va davanti a una telecamera ha una grossa responsabilità nei confronti del pubblico. Purtroppo, in questa logica televisiva, succede poi che studiosi assolutamente validi e che usano il giusto gergo nel trattare temi a livello divulgativo siano completamente ignorati, solo perché non sono anche “personaggi” ma solo “persone”. Un caso tra tutti: Alessandro Barbero. Bravissimo storico e divulgatore, non avendo potuto usufruire di grandissime platee televisive non ha il seguito che senza alcun dubbio merita, a mio parere. Infine, va detto, purtroppo c’è anche una forma di sensazionalismo documentaristico, e girando canale lo si può spesso incrociare. Quindi occorre serietà e rigore, sempre. Il pubblico deve saper essere smaliziato e più critico per evitare di incappare nel trash, e deve saper essere maggiormente selettivo nella scelta dell’offerta culturale. Personalmente, l’esperienza che ricordo con maggior affetto e che ritengo sia stato il culmine della mia attività, è stata quella della produzione di Andrea Vogt sul Colosseo, “Coliseum: the whole story”. Ho lavorato in questo documentario dove sono presenti esperti a livello mondiale come il prof. Darius Arya, come la dott.ssa Rossella Rea, all’epoca direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, e la dott.ssa Federica Guidi, una delle maggiori esperte italiane sulla storia dei gladiatori. Il documentario è stato trasmesso da Discovery Channel e da History Channel e tradotto in tutte le lingue del mondo, io l’ho visto anche in montenegrino. C’è di che esserne davvero orgogliosi.
Giorgio Franchetti si interessa di storia romana da decenni. Si è formato in Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università della Tuscia e poi presso Roma Tre, ha collaborato e preso parte a documentari di importanti tv del settore storico documentaristico, da Ulisse di Alberto Angela a The National Geographic Channel. Ha scritto molti articoli di storia per diverse testate come Hera, Ars Historiae, Civiltà, BBC History e ha tenuto diverse lectiones magistrales presso l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università La Sapienza e presso l’Università di Salerno. È apparso come esperto in un documentario sul Colosseo prodotto da Viasat e tradotto in tutte le lingue del mondo per il circuito Sky (Coliseum: the whole story) ed è stato il protagonista narrante e l’esperto storico per 8 puntate sui gladiatori trasmesse nel 2014 da RAIDUE per la serie Fattore ALFA. Ha diretto documentari e cortometraggi storici di cui ha curato anche la sceneggiatura. Per le Edizioni Efesto ha pubblicato il saggio storico “Panem et Circenses – Vita e morte nell’arena” (2014, tradotto in inglese e francese e classificatosi al 4° posto al concorso nazionale letterario Vittorio Alfieri nel 2016) e “Sangue sulla Decima Legione”, romanzo thriller storico (2015) e “A Tavola con gli Antichi Romani”, saggio storico (2017). Ha scritto la prefazione del saggio sul fenomeno dei gladiatori “Miseria e Fortuna: gli schiavi nella Roma antica” (2016) dello storico Stefano Azzone, del saggio “L’arte della cura. La regola sanitaria salernitana e la teoria dei 4 umori” dell’archeologa Ilenia Tamburro (2019) e di vari romanzi storici, da “Veritas filia temporis. Agguato sull’Aventino” di Alessandro Benin (2017), a “Nemesis. Roma non dimentica” di Riccardo Sciuto. Attualmente sta ultimando la stesura del suo nuovo saggio “A Tavola con gli Etruschi”, che vedrà la pubblicazione nei primi mesi del 2022.
Giuseppina Capone

 Il “limite”, attraverso i temi del confine, del gioco, del silenzio e dello stile in filosofia, è da anni al centro dei suoi lavori. Ebbene, “L’esercizio della filosofia” quale ulteriore apporto offre a “Voci di confine. Il limite e la scrittura” ed a “Ludus Mundi. Idea della filosofia”?
Il “limite”, attraverso i temi del confine, del gioco, del silenzio e dello stile in filosofia, è da anni al centro dei suoi lavori. Ebbene, “L’esercizio della filosofia” quale ulteriore apporto offre a “Voci di confine. Il limite e la scrittura” ed a “Ludus Mundi. Idea della filosofia”?

 Questo è un libro che gratta il fondo della sfera affettiva; vaglia meticolosamente i sentimenti, emozione, ossessione, attrazione, passione, per poi scaraventarli, di nuovo, sul fondo, senza sterili edulcorazioni.
Questo è un libro che gratta il fondo della sfera affettiva; vaglia meticolosamente i sentimenti, emozione, ossessione, attrazione, passione, per poi scaraventarli, di nuovo, sul fondo, senza sterili edulcorazioni.


 28, unione panica con la natura nonché rilievo del poeta nel mondo coevo. Paiono tematiche prive di un fil rouge. E’ possibile, invece, scorgere una traccia che le inanelli?
28, unione panica con la natura nonché rilievo del poeta nel mondo coevo. Paiono tematiche prive di un fil rouge. E’ possibile, invece, scorgere una traccia che le inanelli?

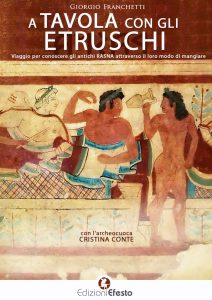 “A tavola con gli antichi romani” ed in uscita “A tavola con gli Etruschi”.
“A tavola con gli antichi romani” ed in uscita “A tavola con gli Etruschi”.

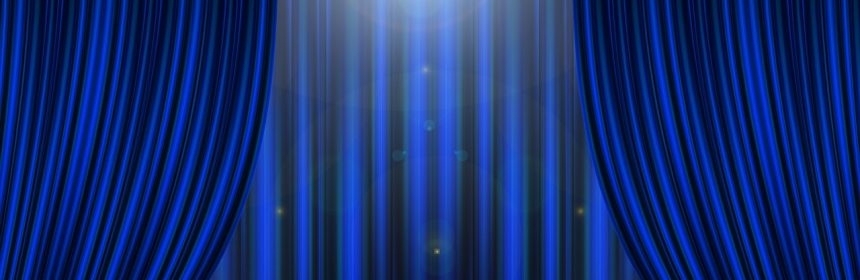
 L’iniziativa nasce da riunioni amichevoli all’ombra di una pianta di more, come lascia trasparire il titolo, e dalla sensibile percezione, da parte di Evelina De Felice, di una istanza di socializzazione indomita, a dispetto di ogni pandemia, che l’attrice ha acutamente coniugato alle preclare virtù del teatro.
L’iniziativa nasce da riunioni amichevoli all’ombra di una pianta di more, come lascia trasparire il titolo, e dalla sensibile percezione, da parte di Evelina De Felice, di una istanza di socializzazione indomita, a dispetto di ogni pandemia, che l’attrice ha acutamente coniugato alle preclare virtù del teatro.
