 Rossella Lisoni, Canterbury Tales è la fonte letteraria alla quale Pasolini si è ispirato per la realizzazione del suo film.
Rossella Lisoni, Canterbury Tales è la fonte letteraria alla quale Pasolini si è ispirato per la realizzazione del suo film.
Quali caratteristiche possiede la narrazione di Chaucer ed in qual maniera è assorbita ed adottata da Pasolini nella produzione cinematografica in esame?
E’ lo stesso Pasolini ad asserire nella “Revue du cinéma image et son” a proposito del suo film I Racconti di Canterbury che egli non ha mai avuto l’ambizione di fare un film in inglese come se fosse un film in inglese, in quanto sapeva già prima di iniziarlo che sarebbe stato il punto di vista di un italiano che ha letto I Canterbury Tales e la notte ha sognato I Canterbury Tales.
Portando sullo schermo I Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer nel 1972 egli getta lo sguardo ad un’opera letteraria lontana nel tempo (“sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore” dirà il poeta in Poesia in forma di rosa), come se soltanto nel passato potesse ritrovare una dimensione gioiosa e incontaminata del vivere quotidiano e l’immagine di un eros liberamente vissuto.
I testi letterari ai quali attinge nei tre film de La Trilogia della vita “”Il Decameron”, I Racconti di Canterbury” e “Il Fiore delle 1000 e una notte” diventano nelle mani di Pasolini dei pre- testi, delle tracce narrative sulle quali costruire il suo personale discorso poetico, a volte distante dall’ideologia dell’autore preso in esame.
Certamente con “La Trilogia della vita” Pasolini fa esplodere certe tensioni presenti fin dall’inizio della sua produzione poetica, quello che ne “La religione del mio tempo” viene definito come “L ‘innocente bene della vita” Pasolini lo trovava un tempo nell’Africa nera (“Appunti per un’Orestiade africana”) e nell’India “Appunti per un film sull’India”), terre vergini ma non in grado di sottrarsi all’intervento di un Capitale che ne deforma il volto.
Negli anni 70 Pasolini si volge a riconsiderare un passato lontano dove ha origine la letteratura popolare, quindi una realtà autentica e sarà questa la filosofia che attraverserà per intero “La Trilogia della vita”.
Il desiderio di comunicare per far nascere la riflessione lascia ora con il film ‘I Racconti di Canterbury” il posto al piacere di fare, di raccontare per il piacere di raccontare.
Ricerca nostalgica quella di Pasolini, che sfugge alla logica della decadenza e rimanda ad un universo transtorico, per questo il Chaucer di Pasolini perde quasi del tutto ogni connotazione storica.
Pasolini si muove su due direzioni contrapposte: da un lato ignora la pagina chauceriana, il fatto cioè che il testo di Chaucer risenta di un’epoca gaudente che esce dalle paure medievali e si avvia a una concezione umanistica della vita e dall’altro Pasolini coglie, con colori lividi e atmosfere cupe, il momento in cui si afferma la società borghese, quell’economia mercantile che inesorabilmente finisce per imporre la propria logica perversa all’universo popolare e ai valori che lo caratterizzano.
Pasolini deideologizza il testo di partenza, ma dello stesso conserva la visione di un’età di trapasso epocale che porta con sé certezze passate e dubbi future.
Pasolini comprende che Chaucer prevede tutte le vittorie della borghesia, ma anche la sua fine .
Egli parla di una ricostruzione chauceriana visionaria, non un pretesto per ricostruire un mondo lontano dal punto di vista storico, in quanto la storia nel suo film è pura visione.
L’immaginario letterario e l’attività giornalistica di Paolini nella sua produzione cinematografica.
Ha ritrovato segni, rimandi, riverberi?
Fu lo stesso Pasolini ad affermare che “un poeta scrive sempre la stessa poesia e un regista gira sempre lo stesso film”. Gli assunti della sua poesia, dei suoi romanzi, dei suoi scritti corsari animano i suoi film. L’ amore viscerale per la propria terra e in seguito per le borgate romane, il tema dell’eros mai disgiunto da thanatos, il dissidio tra istinto e ragione, la critica ai valori della borghesia divenuti per Pasolini dei disvalori, assunti tipici delle sue poesie (“Poesie a Casarsa”,” La religione del mio tempo”) e dei suoi romanzi (“Ragazzi di vita”, “Una vita violenta”) confluiscono nel suo cinema. Sia nel cinema degli esordi, in cui è descritto il mondo sottoproletario e il suo cammino verso la morte (Mamma Roma, Accattone), che nel film “storico”: “Il Vangelo secondo Matteo”, in cui la storia del Cristo aderisce all’ottica dei film prima analizzati, con evidenti richiami al mondo contadino, il cui dialetto era stato analizzato nelle prime produzioni poetiche (“Poesie a Casarsa” e La meglio gioventù), che nel cinema di denuncia (Teorema), che nei i film in cui riecheggia la realtà storica a la propria biografia esistenziale servendosi del mito (Edipo Re, Medea) che infine nei 3 film de “La trilogia della vita”: Il Decameron, I Racconti di Canterbury e Il Fiore delle mille e una notte, in cui l’eros è un valore da contrapporre all’odiato presente, a quell’universo borghese che degrada la realtà. La differenza tra letteratura e cinema, sottolineerà il Pasolini teorico del cinema, sta nel maggior grado di realtà che quest’ultimo rispetto a quella riesce ad assicurare. Il confronto con la morte, inteso come assunto ossessivo, è un dato ricorrente nell’intera produzione pasoliniana, è l’espressione del suo sentire profondo. Nel film I Racconti di Canterbury l’idea della morte ci accompagna lungo tutto il corso del film e la morte vestirà i panni del protagonista nel Racconto dell’indulgenziere. Sarà la morte ad avere la meglio su tutti, quasi a sottolineare che nel duello con la morte si esce sempre perdenti e che la vita termina là dove regna il denaro, cioè la corruzione. Il morire evocato sugli schermi pasoliniani si rivela come un non senso precipitato, quasi un improvviso non rendersi conto, pensiamo alla morte del quarto marito nella Novella della Donna di Bath. E’ quello degli anni 70 un Pasolini “corsaro” critico si della modernità derivante dall’omologazione delle conoscenze e della cultura operante direttamente dal potere e indirettamente dai mass-media, ma sempre in maniera contraddittoria (“per chi è crocefisso alla sua razionalità straziante, la rivoluzione non è più che un sentimento”). La qual cosa non gli impedisce di far salve le ragioni della poesia. Sarà lo stesso Pasolini a distinguere un cinema di poesia, al quale egli stesso tende, un cinema nel quale la macchina da presa fa sentire la sua presenza attraverso le riprese in soggettiva, da un cinema di prosa in cui certi procedimenti stilistici sono assenti.
Chaucer, probabilmente, offre a Pasolini un’occasione per elevare e glorificare il corpo nella sua dimensione più appagante e favolosa.
Quale idea emerge in relazione all’eros?
L’operazione che compie Pasolini ne I Racconti di Canterbury è ridurre il “dialogismo” Chauceriano e convertirlo in fatto visivo. La riconquista del reale va vista nei procedimenti tecnico espressivi impiegati dal regista, cioè nelle scelte di scrittura che rendono autonoma un’opera che trae pur sempre spunto da un testo letterario.
Se il visibile è sottoposto alle leggi sociali e il discorso è limitato da un ordine imposto da un sistema ideologico, gli scarti tra l’uno e l’atro rappresentano i momenti in cui Pasolini può proporre l’autentico, la verità che il sociale reprime.
Far vedere il corpo nella sua integrità, mostrare l’atto erotico sullo schermo sono pratiche attraverso le quali l’intelletto fa irruzione sullo schermo, nella sua completa oscenità, in una società che tiene distante la sua esibizione.
Il regista interviene in maniera significativa sulla pagina scritta: ricondurre il dialogo sulla sfera del visivo non significa solo rendere omaggio ad un cinema che non esiste più, ma anche tenere cose e figure umane in campo mute, affinché il gesto, la corporeità fisica, anziché la parola, diventino elemento primario significante.
I Racconti di Canterburiy all’idea del corpo come vitalità, che era già stato del “Decameron” e che ritroveremo nel “Fiore delle 1000 e una notte” aggiungono un’immagine di questo stesso corpo completamente opposta.
Aleggia infatti all’interno del film un’idea di morte, di disfacimento fisico, di caducità dell’esistere che è presente soltanto parzialmente nel testo letterario di Chaucer.
Nel film sono presenti un corpus di novelle in cui l’eros è mostrato quale momento di liberazione e pienezza di vita, gioia del corpo e al contrario altre in cui l’eros sfocia nel thanatos, in cui emergono valenze tanatologiche nel momento in cui la società reprime la carica erotica, vitale dell’eros.
Allorché i corpi dei protagonisti delle novelle appaiono coperti esprimono una mercificazione e in ombra esprimono il peccato, come nel Racconto del Mugnaio, nel Racconto del Mercante, Racconto della Donna di Bath, mentre quando i corpi sono mostrati nudi e illuminati dalla luce del sole indicano una valenza positiva.
Nel Racconto del Fattore, la figlia del Mugnaio, la sola capace di dire la verità, ci appare nuda e illuminata dalla luce del sole. La sola figura femminile investita di un ruolo positivo e capace di esprimere un sentimento autentico, sganciato cioè dalla morale mercantile.
Nell’insieme però nel film il linguaggio del corpo non riesce a trasmettere una solare vitalità, comunica un senso di inerzia, di morte, di oppressione, unica eccezione la danza di Ninetto Davoli nel Racconto del Cuoco, danza che appare come una vana speranza.
Eros e Thanatos: è un connubio necessario ed imprescindibile? Inoltre, quanto è incisivo il contesto in cui si esprimono?
La morte, come più volte ricordato, rappresenta un assunto fondamentale nell’opera pasoliniana.
Presenta già nei primi componimenti poetici (Poesie a Casarsa) e nei suoi romanzi (Ragazzi di vita, Una vita violenta), trova nel cinema la completa rappresentazione.
Sarà lo stesso Pasolini ad affermare che la libertà è “libertà di scegliere la morte” e sarà proprio thanatos, come lato oscuro di eros, a rappresentare uno dei cardini de I Racconti di Canterbury.
Nel film è presente una morte medievale, allegorica e come ricorda Pasolini ” morte nello stesso momento volgare fino all’abiezione”. La strada affollata di uomini vivi del film diviene nel finale del film un gruppo mortuario, quasi una discesa all’inferno per gli uomini che hanno venduto le loro anime al diavolo per ottenere un profitto economico.
L’ idea della morte che aleggia nel film non è associata all’idea del pellegrinaggio medievale, con mortificazione della carne, digiuni, silenzi, preghiere, ma al contrario siamo immersi in un’atmosfera paganeggiante, il cui principale interesse è costituito dal profitto economico.
Il senso religioso è svanito e l’umanità ha perso i suoi valori fondamentali la punto da vendersi il velo di Maria.
Viene esaltato il valore della parola, come religiosità , come comunicazione ma soltanto per propagandare il valore del guadagno cioè thanatos.
Fine di ogni valore e morte in senso allegorico dell’eros cioè della religiosità,
Morte dell’anima ma non della carne, non più in grado però di procurare all’uomo felicità.
Pasolini dichiarò: “I racconti di Canterburysono stati scritti quarant’anni dopo il Decameron ma i rapporti tra realismo e dimensione fantastica sono gli stessi, solo Chaucer era più grossolano di Boccaccio; d’altra parte era più moderno, poiché in Inghilterra esisteva già una borghesia, come più tardi nella Spagna di Cervantes. Cioè esiste già una contraddizione: da un lato l’aspetto epico con gli eroi grossolani e pieni di vitalità del Medioevo, dall’altro l’ironia e l’autoironia, fenomeni essenzialmente borghesi e segni di cattiva coscienza.»
Può commentare tale asserzione alla luce dei suoi studi?
The Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer costituiscono un punto di riferimento basilare per una teoria dei generi tra Medioevo e Rinascimento, poiché sono una summa di forme e stili.
Con Chaucer la letteratura inglese del Middle English raggiunge la sua più alta espressione.
Egli diviene, per le sue proprie qualità, uno scrittore dotato di risorse tecniche, versatile e universalmente ammirato in tutto il medioevo inglese.
Il Medioevo di Chaucer è un’epoca in declino, i capisaldi del mondo medievale: la Chiesa e l’Impero mostrano segni di decadenza.
La borghesia, che con l’arma della satira trionfa sulle vecchie istituzioni, impone il richiamo alla religione.
Per il poeta il mondo dei sensi, lungi dall’essere una realtà intangibile, è un universo desiderabile anche nella sua caducità.
In qualità di gaudente, egli sa apprezzare tutto ciò che è terreno, non facendosi influenzare da preoccupazioni ultramondane, ma al contrario godendo di una serenità non riscontrabile negli altri scrittori medievali e riuscendo a ricavare dall’osservazione ironica, ma anche comprensiva dei suoi simili, quel genere di divertimento del quale solo l’artista sa godere. L’ambiente economico e sociale con le sue inquietudini e i suoi sconvolgimenti viene filtrato attraverso il carattere dei personaggi e trasfuso in esempi individuali e di egoismo e furfanteria, descritti con quello stesso interesse e gusto per il comportamento degli uomini e per le loro debolezze che si ritroverà in Shakespeare.
Il punto di vista di Chaucer è sempre quello di un laico, nonostante le testimonianze di un genuino sentimento religioso.
Egli nel suo complesso si mostra più attratto che scandalizzato dalle debolezze della natura umana.
Non un giudizio duro o un’aspra critica muove la volontà di Chaucer, bensì l’accettazione e la giustificazione di ogni creatura umana e la scoperta in essa di una profonda umanità.
Chaucer è volto al divertimento ed esalta la borghesia, come classe sociale produttiva e socialmente utile.
La grande capacità di Chaucer è la chiacchiera, i narratori più che narrare chiacchierano, le storie che raccontano sono un pretesto per dei meravigliosi pezzi di bravura comico-moralistica, con un’ infinità di citazioni preziose, di magniloquente didattiche fintamente arcaiche.
Chaucer, all’interno dell’opera, ha una duale identità, sia di autore che di pellegrino, elemento fondamentale che, insieme alle sue doti di narratore e umorista borghese, lo rendono quasi un antenato dei romanzieri del settecento inglese.
Il suo punto d’osservazione, anche se ironico, è sempre centrale, il tono anche se comico, mai buffo e ognuno dei suoi personaggi rappresenta una qualche verità essenziale dell’uomo, da qui la sua estrema raffinatezza.
Rosella Lisoni nasce a Marta in provincia di Viterbo, si laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne e Contemporanee presso l’ Università degli Studi della Tuscia con una tesi sul cinema di Pasolini. Inizia la sua attività lavorativa insegnando lingua francese, attualmente lavora nella Segreteria di Direzione del Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali I -DIBAF, presso l’ Università della Tuscia.
Per anni ha scritto recensioni cinematografiche sulla rivista Cinema60.
Ha collaborato su un quotidiano on line di Viterbo e attualmente collabora con la rivista culturale L’ Ottavo.
Nel luglio 2020 ha pubblicato un saggio su Pasolini dal titolo: “Eros e Thanatos ne I Racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini”.
Giuseppina Capone

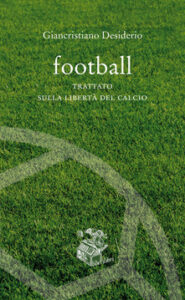 Jean Paul Sartre scrive: «Il calcio è la metafora della vita».
Jean Paul Sartre scrive: «Il calcio è la metafora della vita».
 Rossella Lisoni, Canterbury Tales è la fonte letteraria alla quale Pasolini si è ispirato per la realizzazione del suo film.
Rossella Lisoni, Canterbury Tales è la fonte letteraria alla quale Pasolini si è ispirato per la realizzazione del suo film.

 Nympha, come racconta Ovidio di Clizia, può essere vittima di Eros.
Nympha, come racconta Ovidio di Clizia, può essere vittima di Eros.
 Dodici ritratti di altrettante donne, un caleidoscopio di universi femminili, dissimili quanto ad età, condizione, ruolo sociale, esperienza esistenziale. Qual tratto le accomuna?
Dodici ritratti di altrettante donne, un caleidoscopio di universi femminili, dissimili quanto ad età, condizione, ruolo sociale, esperienza esistenziale. Qual tratto le accomuna?
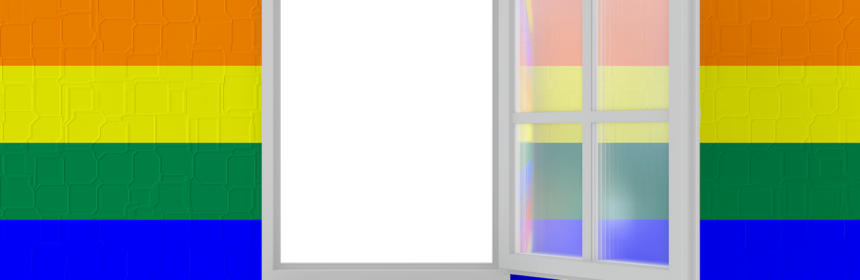

 Le sue righe suggeriscono l’amore come un sentimento che intrappola, che non dà scampo e non prevede vie di fuga: Elena e Paride infrangono ogni regola, ogni convenzione narra Omero. Ebbene, non si sceglie d’amare né d’essere amati?
Le sue righe suggeriscono l’amore come un sentimento che intrappola, che non dà scampo e non prevede vie di fuga: Elena e Paride infrangono ogni regola, ogni convenzione narra Omero. Ebbene, non si sceglie d’amare né d’essere amati?


