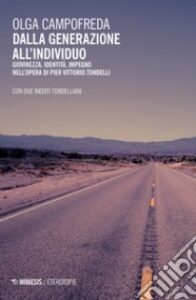Olga Campofreda è dottore di ricerca in letteratura italiana. Vive a Londra, dove insegna presso l’Istituto di Cultura Italiano e alla UCL. Nel 2019 ha pubblicato A San Francisco con Lawrence Ferlinghetti (Giulio Perrone Editore), con lei abbiamo parlato del suo libro “Dalla generazione all’individuo. Giovinezza, identità, impegno nell’opera di Pier Vittorio Tondelli” edito da Nimesis.
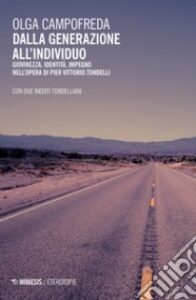
Olga Campofreda, chi è Pier Vittorio Tondelli e quali peculiarità riserva la sua produzione?
Pier Vittorio Tondelli (o PVT, come spesso viene riportato con un’operazione simile alla “brandizzazione”) è stato uno scrittore italiano omosessuale che ha esordito nel 1980 con l’opera-scandalo “Altri libertini”, un romanzo che portava dentro tutta l’esperienza del Settantasette bolognese, ma anche molto altro: oltre la superficie fatta di simboli, atteggiamenti e linguaggi legati a quel periodo storico, questo libro racconta la provincia italiana lontana dai grandi centri, vite marginali ed emarginate, questi “altri” libertini, appunto, che sono poi a mio avviso il tema centrale di tutta la riflessione letteraria di Tondelli fino alla morte per AIDS, avvenuta nel 1991.
Prima ho parlato di “brandizzazione”: come racconto nell’introduzione del mio saggio, la critica si è espressa in modo particolarmente problematico su questo autore nel corso degli anni. Tondelli è stato il primo dei giovani scrittori degli anni Ottanta, un gruppo di autori messi insieme per ragioni di marketing editoriale (tra questi anche Andrea De Carlo, Enrico Palandri, Claudio Piersanti, per un periodo anche Daniele Del Giudice). In questo contesto, Tondelli è ricordato più di tutti per aver parlato di giovani ai giovani, trascinando a lungo su di sé le etichette della ribellione e del giovanilismo. Questo ha contribuito a eclissare altri temi più profondi, come appunto il significato reale delle giovinezze ribelli narrate. Oltre alla “brandizzazione” di questo autore, altra problematica è rappresentata dall’interesse morboso per la sua vita privata, specialmente intorno alla questione dell’omosessualità: cercare risposte biografiche nei suoi romanzi, non ha aiutato certamente a valorizzarne il lavoro letterario in quanto creazione di simboli intorno a un discorso più universale.
Lei ha manifestato l’intento di “liberare l’opera tondelliana dal contesto generazionale e da una fruizione limitata a un interesse documentario.” A quale scenario storico sono riconducibili i personaggi tondelliani e qual è il valore simbolico del mondo di giovani emarginati di cui narra?
Prima ho parlato della Bologna del Settantasette, che esce fuori principalmente dai racconti di “Altri libertini” (1980). Molti critici hanno parlato di Tondelli come di un autore generazionale, ergendolo a rappresentante di una determinata generazione e incasellandolo in un contesto storico, che senza dubbio è fortemente presente nei suoi romanzi. Ma Tondelli è anche e soprattutto gli anni Ottanta italiani, nel corso dei quali ha prodotto l’intera sua opera letteraria. Anni che ha osservato e interpretato attraverso reportage, articoli di giornale, rubriche.
La scrittura tondelliana ha assorbito moltissimo la realtà italiana nella quale l’autore era immerso, ma se ci si limitasse solo a questo Tondelli non sarebbe né più né meno che un attento giornalista, e le sue opere un documento. Ricordo benissimo una domanda – fondamentale – che mi ha fatto lo scrittore Enrico Palandri all’inizio della mia ricerca: che cosa resterà tra tantissimi anni dei romanzi di Pier Vittorio Tondelli? Che cos’è letteratura, al di là degli elementi biografici o generazionali? Provando a rispondere a questi interrogativi, ho capito che la giovinezza, tema ossessivamente riproposto dalla pagina tondelliana, ha in verità una carica simbolica fortissima. Il giovane, in particolare il giovane emarginato, è l’individuo ancora in formazione, ancora libero dal punto di vista identitario e non assoggettato agli incasellamenti della società borghese conservatrice.
In che misura la narrativa di Tondelli diverge dal romanzo di formazione così come codificato dalla tradizione, considerando la presenza da protagonisti di emarginati che rifiutano l’integrazione come prospettiva?
Il romanzo di formazione, così come già fa notare Franco Moretti nei suoi studi sul tema (1999), è un genere letterario prodotto da una società borghese in un determinato periodo storico, fondato su determinati valori che oggi definiremmo conservatori e senza dubbio eteronormativi. Nel corso del novecento il genere è stato usato per descrivere storie di adolescenze e di giovinezze in generale, pur mantenendo la sua natura conservatrice di fondo. Si tratta di un percorso che accompagna il giovane verso l’età adulta, che verrà raggiunta una volta conquistate le sfere del lavoro, di una famiglia (eterosessuale, è chiaro), del riconoscimento in una patria. I personaggi tondelliani sono giovani per i quali non solo questo percorso non funziona, ma viene proprio rifiutato per i valori che rappresenta. La scelta di una giovinezza come status permanente ha un valore politico fondamentale. Raccontare personaggi di questo tipo, nel modo in cui fa Tondelli, è un punto di svolta importante per la letteratura italiana: significa mostrare strade alternative fondate su un sistema di valori nuovo, inclusivo, anti-normativo.
“La rappresentazione della giovinezza coincide nel romanzo d’esordio con quella di un mondo di emarginati che vivono volutamente oltre i confini della società borghese fondata principalmente sul concetto di omologazione e su valori eteronormativi”. Ha pensato ad una fusione dell’ideale romantico con quello della Beat Generation e della “controcultura”?
Esattamente. Parlo di questa fusione di ideali e immaginari nel primo capitolo del saggio, in particolare in relazione ai due inediti Jungen Werther/Esecuzioni e Appunti per un intervento teatrale sulla condizione giovanile. Questi inediti, databili alla fine degli anni Settanta e quindi precedenti all’esordio di Tondelli, già raccolgono in nuce i nuclei principali del discorso letterario tondelliano. Il primo inedito presenta cinque eroi che scelgono il suicidio come affermazione della propria diversità contro un mondo, quello borghese, che li vuole integrare solo a patto di sottostare a determinati parametri. Nel secondo inedito il rifiuto del “mondo degli integrati” è invece interpretato attraverso l’allontanamento, il viaggio come strumento di formazione alternativa a quella imposta dalla società conformata. I libertini dell’esordio nascono da questo innesto: il romanticismo abbandona il suicidio come unica opzione di resistenza possibile, sfumando nell’epica della Beat Generation.
“La giovinezza è l’immaginario della dissidenza, della difesa delle voci diverse, è l’anti-kitsch-piccolo-borghese, è il linguaggio dell’individuo che si allontana dalla massa. L’opera di Tondelli si sviluppa lungo un percorso che passa dall’impegno collettivo a quello del singolo, dalla generazione del Movimento del ’77 alle voci individuali degli anni Ottanta. Questa esperienza si sviluppa parallelamente a un sistema teorico ben ponderato che nasce dall’esigenza di offrire un’alternativa ai giovani Werther e ai giovani Ortis ai quali solo il suicidio si proponeva come valida azione sovversiva in difesa dell’identità”.
Come ci si salva dal conformismo, dal convenzionalismo, dall’asfissiante rispetto dei codici?
Il linguaggio è la forma che diamo alla realtà. Le parole che scegliamo e poi usiamo, più o meno consapevolmente, sono sempre portatrici del nostro punto di vista sul mondo. Si caricano di un certo sistema di valori. La consapevolezza nell’uso della lingua è certamente un passo importante verso la liberazione dal conformismo, quello che Tondelli chiamava “letterarietà” non certo pensando alla letteratura, ma all’insegnamento della lingua che avviene presso l’istituzione scolastica. Questo è un punto decisivo nell’impegno di Tondelli ed è anche l’aspetto che più lo avvicina a Pasolini: il linguaggio burocratizzato della politica, quello della pubblicità, quello della società di massa allontana le parole dal dettaglio e dall’autenticità. L’invito è quello a ricercare una lingua che sia quanto più possibile autentica, sia essa esuberante come il linguaggio dei libertini o minimale e scarna come in Camere separate.
Giuseppina Capone


 Il suo romanzo ha una costruzione “a specchio”. Quanto diverge dal genere codificato dalla tradizione e qual è la tecnica che ha adottato?
Il suo romanzo ha una costruzione “a specchio”. Quanto diverge dal genere codificato dalla tradizione e qual è la tecnica che ha adottato?
 Cos’è la “lanterna nera” e quali furono i suoi effetti?
Cos’è la “lanterna nera” e quali furono i suoi effetti?




 Si reputa che la intimate partner violence si riveli una strategia per “fare il genere”, e per “fare le maschilità”. La polisemia di accezioni (genere linguistico, biologico e sociale) che la lingua sviluppa dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?
Si reputa che la intimate partner violence si riveli una strategia per “fare il genere”, e per “fare le maschilità”. La polisemia di accezioni (genere linguistico, biologico e sociale) che la lingua sviluppa dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?
 Per quale ragione, oggidì, sono le donne a scandire la grande lotta del movimento ecologista?
Per quale ragione, oggidì, sono le donne a scandire la grande lotta del movimento ecologista?