C’è solo l’andare senza fermarsi:/ se i piedi il sonno volesse mangiarseli/
è permesso cadere, non addormentarsi.
Lei scrive versi che narrano una quotidianità quasi atemporale, in cui si stenta a riconoscere il contesto storico in cui la vita si svolge. La vita umana vive una costante condizione di anonimato?
Non ne farei una questione di anonimato, se con questo si intende una condizione in cui sia dominante una passività di fondo o l’inutilità di ogni ricerca di senso.
L’assenza di coordinate storiche e una certa atemporalità possono suggerire a mio avviso un’altra possibilità: quella di rendersi conto che ogni essere vivente, non solo umano, indipendentemente dal contesto in cui vive e dalla sua specifica identità, è parte di un “tutto” di cui, questo sì, spesso ci sfugge l’enorme complessità. Ma non mi sembra un dato sminuente o avvilente, anzi… dovrebbe contribuire ad accendere curiosità, senso di reciprocità…
Per venire al nostro ambito, credo nella possibilità della poesia come fotografia di un processo in continuo divenire, più che come affermazione dell’io che la produce. Del resto, per dirla con Rimbaud, “Io è un altro. Se l’ottone si sveglia tromba, non è affatto colpa sua…”
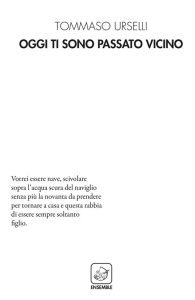 Lei sta spendendo il suo tempo quale autore di teatro. In un tempo politico, sociale ed economico che grida l’impellente bisogno di tessere un dialogo con sé stessi, la conflittualità interiore può essere lenita dalla Poesia?
Lei sta spendendo il suo tempo quale autore di teatro. In un tempo politico, sociale ed economico che grida l’impellente bisogno di tessere un dialogo con sé stessi, la conflittualità interiore può essere lenita dalla Poesia?Qualche mese fa, lo scorso maggio, una compagnia teatrale con cui avevo precedentemente collaborato come drammaturgo mi ha proposto di tenere una giornata di laboratorio di scrittura poetica rivolto agli allievi di un corso di formazione teatrale.
Si trattava per me della prima volta dopo tempo, di un incontro di lavoro in presenza, e non ho saputo fare di meglio che pensare di dare lo stesso titolo del libro che avevo composto durante il lockdown, “Oggi ti sono passato vicino”; non per mania di autoreferenzialità (durante il lavoro non sono stati utilizzati testi dal libro) ma perché nelle mie intenzioni esso contiene e racconta di un desiderio, una necessità che tutti abbiamo avvertito in questo periodo, sia pure in maniere e declinazioni differenti: quello di stringersi, di fare fronte comune dinanzi a qualcosa di sconosciuto, in una situazione in cui proprio la possibilità di essere uniti veniva per forza di cose a mancare. Come tradurre allora questa necessità in una pratica realizzabile?
Da circa venti anni mi occupo di drammaturgia. Scrivere per il teatro significa scrivere per degli attori che porteranno sulla scena il tuo lavoro… niente di più impensabile durante il lockdown, in cui come autore teatrale sono stato decisamente in lutto… mi era del tutto impossibile pensare di scrivere qualcosa che sarebbe andato in scena “dopo”, in un momento in cui i teatri erano chiusi, morti… il teatro non è fatto di “dopo”, è fatto di “adesso”, un adesso da condividere corpo a corpo: corpo del drammaturgo, corpo del regista, i corpi degli attori, i corpi degli spettatori… Così la mia scrittura ha cercato altre strade, già frequentate in passato anche se non in maniera sistematica: dalla rivisitazione di quegli sporadici tentativi in versi e dalla composizione di testi ex-novo, ha così pian piano preso forma questo libro, che porta in sé le tracce di una necessità evidente fin dal titolo (anche se quasi mai nei testi c’è esplicito riferimento al tema del virus e della pandemia, tranne che in una composizione).
Dunque, tornando al laboratorio, la cosa che ho sentito più sensata e organica, è stata quella di trasformare in oggetto di lavoro di gruppo la pratica di scrittura in versi che mi aveva accompagnato durante il lockdown – badando di non cedere alla tentazione di farne una ricetta o un manifesto, ma di restare sempre nell’ambito dell’interrogativo, a sé e al gruppo – da cui il sottotitolo:
“Nella distanza dei corpi, può la poesia avvicinare? Un laboratorio di incontro attraverso la scrittura.”
Quale “lenimento” migliore della condivisione?
Ti sento, è la tua voce, il tuo/ articolare lento e cadenzato. /Oggi ti sono passato vicino.
La sua versificazione è lucida, nitida, disincantata, priva di edulcorazioni, scevra da vergogne. C’è un limite a ciò che si può narrare?
È una domanda a cui credo sia possibile dare risposte anche molto differenti, e tutte legittime. Quello che conta, a mio parere, è che questa risposta scaturisca da un percorso, una pratica di lavoro che l’autore avverte come necessaria. È questa necessità, forse, a disegnare il limite tra ciò cui è importante dare forma e ciò che può essere tenuto per sé.
I morti, onde del mare/bianca spuma che a lungo ha viaggiato/ e a casa ritorna,/alla madre infinita.
Le parole che inanella in versi appaiono sensibilmente refrattarie al rispetto ovvio ed ossequioso delle norme grammaticali, compromettendo irrimediabilmente la logica connessione lettura-comprensione.
Qual è la chiave d’accesso per discriminare i suoi intenti comunicativi?
Non credo che un autore debba fornire chiavi d’accesso… caso mai, forse, fabbricare porte… Sta poi al lettore la scelta di aprirle o meno, per visitare i luoghi su cui si affacciano; questo a prescindere dalla comprensibilità o meno dei suoi testi e da quelli che potrebbero essere i suoi intenti comunicativi. Ma a proposito di comunicazione, vorrei qui citare la poesia e le parole di Antonio Neiwiller, uomo di teatro che ci ha lasciato nel secolo scorso; in particolare queste righe da un frammento del 1993 (stesso anno della sua scomparsa) dedicato a un altro grande uomo di teatro, Tadeusz Kantor:
“…È tempo che l’arte
trovi altre forme
per comunicare in un universo
in cui tutto è comunicazione…”
(da “l’altro sguardo: per un teatro clandestino, dedicato a t. kantor”)
Ad ogni modo, tornando ai testi della raccolta e ad eventuali strumenti di comprensione, mi riconosco nello sguardo di Franca Alaimo, di cui riporto qui un estratto da una sua nota di lettura:
“… l’autore fa uso di altre esperienze artistiche a lungo praticate, essendosi cimentato con il teatro (si ritrovano, infatti, in molti testi l’estro drammatico, l’impianto dialogico, ma anche l’asciuttezza di un autore grandissimo quale Beckett), e con la musica, specialmente il jazz (da cui provengono il ritmo sincopato di certi testi) … Né escluderei la meditazione buddhista e per l’epigrammatica sapienza di certi versi e per la concezione dell’Uno come inizio e ritorno di ogni cosa in una perenne ciclicità…”
La sua silloge potrebbe scomporsi in quattro momenti: memoria, contemporaneità, teatro, dolore. C’è un filo rosso che le congiunge?
Giocando un po’ a parafrasare Artaud: la vita, e il suo doppio.
Tommaso Urselli è autore di teatro. In passato alcuni suoi componimenti poetici sono stati pubblicati e positivamente recensiti da Maurizio Cucchi su Lo Specchio de La Stampa.
Oggi ti sono passato vicino, da poco pubblicata per Ensemble, è la sua prima silloge poetica; la sezione “Parole alle formiche”, particolarmente apprezzata dal poeta Giuseppe Conte (sue le parole in quarta di copertina), è giunta finalista al Premio InediTO – Colline di Torino 2019. Tra i suoi testi teatrali rappresentati e pubblicati:
Un vecchio gioco (La Mongolfiera Editrice; premio Fersen, Piccolo Teatro di Milano);
Boccaperta (La Mongolfiera Ed.) commissionato da Teatro Periferico;
Ipazia. La nota più alta (pubblicato da Sedizioni, e in e-book da Ledizioni nella versione inglese) su commissione di PactaDeiTeatri;
Il Tiglio. Foto di famiglia senza madre, prodotto dall’autore in collaborazione con l’attore-regista Massimiliano Speziani (il testo, tra i vincitori del premio Borrello per la drammaturgia – e premio Fersen alla regia – è pubblicato sul n. 727 della rivista Sipario, in volume per La Mongolfiera Editrice, in e-book per Morellini Editore); su commissione del Festival Connections – Teatro Litta, Milano, scrive
In-equilibrio; viene prodotto dal Teatro Litta il suo testo
Esercizi di distruzione. L’importanza di chiamarsi Erostrato (pubblicato in volume per Edizioni Corsare e sul n. 758 della rivista Sipario; vincitore del premio Lago Gerundo);
Ma che ci faccio io qua (Edizioni Corsare); cura con Renata Molinari e Renato Gabrielli la pubblicazione di
A proposito di menzogne – testi per Città in condominio, L’Alfabeto urbano, Napoli; scrive inoltre
Canto errante di un uomo flessibile, tra i vincitori del Premio Fersen per la drammaturgia e pubblicato da Editoria&Spettacolo; vince la prima edizione del premio Parole in scena per il teatro-ragazzi con il testo
La città racconta (Edizioni Corsare);
Piccole danze quotidiane (messo in scena al PimOff e presso la Triennale di Milano per il Festival Tramedautore, Outis);
La porta (Festival Tramedautore, Outis; pubblicato da La Mongolfiera Editrice). Blog:
https://tommasourselli.wordpress.com/
Giuseppina Capone

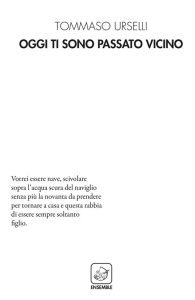 Lei sta spendendo il suo tempo quale autore di teatro. In un tempo politico, sociale ed economico che grida l’impellente bisogno di tessere un dialogo con sé stessi, la conflittualità interiore può essere lenita dalla Poesia?
Lei sta spendendo il suo tempo quale autore di teatro. In un tempo politico, sociale ed economico che grida l’impellente bisogno di tessere un dialogo con sé stessi, la conflittualità interiore può essere lenita dalla Poesia?



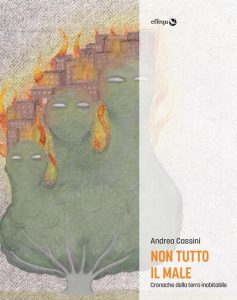 Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?
Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?
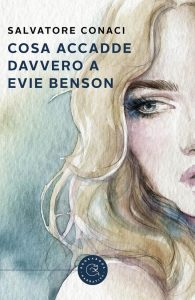 Uno dei temi del romanzo è il dolore muliebre. Perché ha deciso d’illuminare un aspetto troppo spesso taciuto?
Uno dei temi del romanzo è il dolore muliebre. Perché ha deciso d’illuminare un aspetto troppo spesso taciuto?
 Libri riccamente illustrati che raccontano ai giovanissimi lettori le tante storie che hanno visto protagonisti personaggi diventati famosi grazie alla capacità creativa e letteraria dei loro autori, veri giganti della letteratura italiana e internazionale.
Libri riccamente illustrati che raccontano ai giovanissimi lettori le tante storie che hanno visto protagonisti personaggi diventati famosi grazie alla capacità creativa e letteraria dei loro autori, veri giganti della letteratura italiana e internazionale.

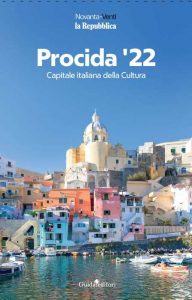 Procida ’22 si inserisce nella collana Novanta/ Venti, fondata nell’aprile di due anni fa, quando la redazione di Napoli di Repubblica, inaugurata il 18 aprile del 1990, festeggiò il trentesimo compleanno, in pieno lockdown. Il volume è curato da Ottavio Ragone e Conchita Sannino. Le parole di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, racchiudono il presente e il futuro della suggestiva isola “Procida può diventare il paradigma di una condizione contemporanea: stare dentro la globalizzazione ma con una propria essenza, riconoscibile e certa, che renda un luogo diverso da ogni altro, lo ponga al centro di relazioni forti e capillari ma al tempo stesso lo preservi con la propria millenaria storia, bella tutela e valorizzazione dell’ambiente”.
Procida ’22 si inserisce nella collana Novanta/ Venti, fondata nell’aprile di due anni fa, quando la redazione di Napoli di Repubblica, inaugurata il 18 aprile del 1990, festeggiò il trentesimo compleanno, in pieno lockdown. Il volume è curato da Ottavio Ragone e Conchita Sannino. Le parole di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, racchiudono il presente e il futuro della suggestiva isola “Procida può diventare il paradigma di una condizione contemporanea: stare dentro la globalizzazione ma con una propria essenza, riconoscibile e certa, che renda un luogo diverso da ogni altro, lo ponga al centro di relazioni forti e capillari ma al tempo stesso lo preservi con la propria millenaria storia, bella tutela e valorizzazione dell’ambiente”.
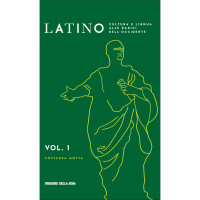 Il latino è la lingua ma anche la cultura “alle radici dell’Occidente” e come tale la ritroviamo ogni giorno anche percorrendo le strade delle nostre città dove vediamo iscrizioni in una lingua, appunto il latino, che è stata la base di una civiltà che ha espanso i suoi confini, fisici e culturali, oltre quelli in cui il nostro Paese è oggi racchiusa. Molte delle nostre città si basano anche sulla struttura urbanistica che da quella civiltà hanno preso consistenza; comprendere la vita e la cultura romana di cui il latino era la lingua non significa solo studiare una fase della storia umana di una popolazione ma anche comprendere la cultura del nostro presente che prende l’avvio da quella.
Il latino è la lingua ma anche la cultura “alle radici dell’Occidente” e come tale la ritroviamo ogni giorno anche percorrendo le strade delle nostre città dove vediamo iscrizioni in una lingua, appunto il latino, che è stata la base di una civiltà che ha espanso i suoi confini, fisici e culturali, oltre quelli in cui il nostro Paese è oggi racchiusa. Molte delle nostre città si basano anche sulla struttura urbanistica che da quella civiltà hanno preso consistenza; comprendere la vita e la cultura romana di cui il latino era la lingua non significa solo studiare una fase della storia umana di una popolazione ma anche comprendere la cultura del nostro presente che prende l’avvio da quella.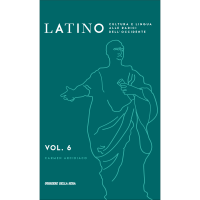 Per meglio comprendere i diversi aspetti i venti volumi prevedono una parte più strettamente storico-letteraria ed una dedicata invece alla lingua e alla sua grammatica. Il tutto corredato da esercizi e giochi per rendere più vicina una lingua bella da imparare o da riscoprire.
Per meglio comprendere i diversi aspetti i venti volumi prevedono una parte più strettamente storico-letteraria ed una dedicata invece alla lingua e alla sua grammatica. Il tutto corredato da esercizi e giochi per rendere più vicina una lingua bella da imparare o da riscoprire.
