 Nei testi che analizza, in che misura il linguaggio usato per raccontare il parto tradisce una tensione tra l’esperienza vissuta e la sua rappresentazione simbolica? C’è una lingua possibile del parto, o è per sua natura indicibile?
Nei testi che analizza, in che misura il linguaggio usato per raccontare il parto tradisce una tensione tra l’esperienza vissuta e la sua rappresentazione simbolica? C’è una lingua possibile del parto, o è per sua natura indicibile?
Ecco: questa è una tra le domande che mi sono posta all’inizio di questa esplorazione. Perché la narrazione della maternità e, in particolare, del parto è così marginale in letteratura? Si tratta di un’esperienza indicibile a parole oppure il silenzio dipende da una differenza di genere, ovvero dalla presenza dominante di autori uomini? In altre parole, perché non c’è una narrazione (e una lingua) che parli della venuta al mondo? Questo libro si propone come un itinerario personale, parziale e incompleto. Una provocazione, un inventario e il tentativo di disegnare una strada per la narrazione di uno dei momenti più enigmatici della vita: la nascita. Tra incanto e disincanto.
Lei menziona autrici che hanno rotto il silenzio sul parto, come Rachel Cusk o Annie Ernaux. Cosa accomuna queste narrazioni e in che modo riescono a scardinare le strutture tradizionali del racconto autobiografico o memoriale?
Annie Ernaux conquista il premio Nobel per la letteratura nel 2022. Ricordiamo la motivazione: “Per il coraggio e l’acutezza clinica con cui svela le radici, gli allontanamenti e i limiti collettivi della memoria personale”. Si tratta di narrazioni autobiografiche e coraggiose ma – ci tengo a sottolineare – anche storiche, in quanto, ad esempio, nell’ottobre 1963 in Francia l’aborto era illegale e la protagonista è costretta a ricorrere a uno dei medici cosiddetti “cucchiai d’oro” oppure a una donna di quelle che venivano chiamate “fabbricanti d’angeli”.
Esiste una genealogia femminile di scrittrici che hanno raccontato la nascita, oppure ogni testo nasce come atto solitario e controcorrente? Si può parlare oggi di una “tradizione” letteraria della nascita? Con Cose che non si raccontano, ad esempio, di Antonella Lattanzi, un romanzo autobiografico racconta con coraggio e fiducia il suo doloroso cammino di madre “orfana” di tre bambine. Questo bellissimo e struggente romanzo è stato anche candidato, in passato, al premio Strega. Mi sembra di vedere l’alba di una maggiore attenzione e sensibilità verso questa tematica.
Quanto il racconto del parto, nella letteratura, è ancora oggi un tabù?
Bisognerebbe avviare uno studio significativo, non semplicemente un’esplorazione, come la mia. Per poter dare una risposta credibile, dovremmo avere in mano una mappatura letteraria significativa diacronica e geografica, che consideri anche il genere dell’autore. Si tratta di scrittrici o di scrittori? Come detto, sento questo mio libro come una provocazione necessaria, un appello, il guanto di sfida che mi auguro venga raccolto. Più che risposte, ho una manciata di significative e spinose domande.
E in che misura questo tabù è diverso da quello sull’aborto, che pure riceve un’attenzione politica e mediatica maggiore? Quanta dose di coraggio è richiesta a una donna per scegliere di essere madre o di non esserlo? Per attraversare questo dilemma.Entrambe le strade sono disseminate di cocci aguzzi di bottiglia.
Lei scrive di “parti narrativi”, “cesarei letterari”, “aborti di trama”. Il linguaggio che adopera è fortemente metaforico: in che modo ha costruito questa grammatica critica per affrontare temi così viscerali senza cadere nel pietismo o nella retorica?
Ho cercato di non essere accademica, né didascalica, né retorica. Il rischio è sempre dietro l’angolo. Il tema, si sa, è viscerale e doloroso, ma poter leggere narrazioni letterarie e di una certa profondità mi pare liberatorio, terapeutico e coraggioso. Inoltre, come dicevo, si tratta di un itinerario, ho cercato le parole, non scientifiche, non medicalizzate, ma letterarie, poetiche.
La narrazione della nascita implica una forte dimensione temporale e liminale. Quali autori hanno saputo esplorare al meglio questa soglia tra vita e non-vita, inizio e fine, dicibile e indicibile? Dante, come sempre, è magistrale e insuperato. Nel canto XXXIII del Paradiso prima di affrontare la visione divina, rivolge un’invocazione alla Madonna, “umile e alta più che creatura” e cesella un paio di ossimori in un unico endecasillabo (il primo di questo canto” rendendo chiaro il mistero divino della “Vergine Madre”, “figlia” di suo “figlio”. La maternità, del resto, nasce sempre da un incontro, da un contrasto.
Nel raccontare il parto, quanto conta la forma (diario, romanzo, poesia, autofiction)? C’è un genere che secondo lei si avvicina meglio all’esperienza corporea della nascita?
Come la morte, di cui è contraltare e controcanto, il momento della nascita resta una pagina tra le più affascinanti e misteriose della vita terrena. Il discorso è davvero antitetico, perché ha a che vedere con il buio e la luce, con quello che si può sapere e quello che ignoriamo, un confine che è fisico e metafisico insieme. Le parole per dirlo quindi possono essere poetiche, prosaiche, filosofiche. Quale scegliere? Sicuramente la parola di fronte al mistero ha una grande responsabilità ed è pur sempre povera, limitata, inadeguata, come l’uomo stesso.
Ha notato un differente “registro” emotivo o stilistico tra le narrazioni maschili e femminili del parto? Se sì, può darci un esempio particolarmente rivelatore?
Prendo a prestito un esempio: ho titolato un capitolo “Ernest Hemingway dietro la porta”. Credo che ci sia sempre qualcuno che chiude una porta per lasciare entrare un bimbo nel mondo. Qualcuno che si mette in ascolto, qualcuno che non c’è e che invece invade, è presenza ingombrante. Il bambino deve sgusciare, nudo e urlante, sul pianeta Terra, venire alla luce ma che la porta sia ben chiusa, eh mi raccomando! In Addio alle armi, il protagonista resta fuori dalla sala operatoria, a fissare, per l’appunto, la porta. In seguito, può “entrare e sapere”. L’interrogativo ad ogni modo riguarda la narrazione: si può raccontare qualcosa di cui non è fatta la prova? Il racconto di un parto da parte di uno scrittore è più autentico e veridico di quello di una donna? E, d’altra parte, Oriana Fallaci nel suo celebre e giustamente celebrato Lettera a un bambino mai nato scrive parole poeticissime che sono certamente frutto di una profonda sensibilità femminile. Basti solo leggere queste, rubate dall’incipit del monologo: “Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto, in quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: sì, c’eri. Esistevi.”
Dopo aver compiuto questo viaggio nei testi, come è cambiata la sua percezione della maternità nella cultura letteraria occidentale? Più disincanto, più rabbia, più empatia?
Dopo aver compiuto questo viaggio, mi sento ancora più assetata di conoscenza. Vorrei esplorare, leggere, conoscere, interrogare altri testi, altre lingue e altre culture. Come detto prima, questo libro apre un ventaglio di domande e ancora mi sento lontana da aver raggiunto una visione panoramica, d’insieme. Insomma, sono ancora all’inizio della salita in questa spedizione, al campo base. C’è da camminare, da conoscere, perché se la letteratura è specchio della vita, dobbiamo togliere un po’ di polvere e guardare meglio il nostro specchio. Qualcuno ha scritto che l’Italia non è un paese per madri (Flavia Gasperetti) ma forse, parafrasando per la seconda volta il celebre titolo, potremmo anche chiedercelo: la letteratura non è un paese per madri?
Linda Terziroli
Nata a Varese nel 1983, si è laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano, con una tesi dedicata a Guido Morselli. Insegna materie letterarie nelle scuole superiori e italiano per stranieri; collabora con La Provincia di Varese e con Lombardia Nord Ovest, periodico della Camera di Commercio di Varese. Ha ideato, insieme a Silvio Raffo, il Premio Guido Morselli e la mostra permanente all’interno della Casina Rosa, dimora dello scrittore, a Gavirate. Curatrice dei volumi Lettere ritrovate (NEM, 2009), Guido Morselli. Una rivolta e altri scritti (Bietti, 2012), si è occupata dello scrittore in diversi saggi e articoli.
Giuseppina Capone
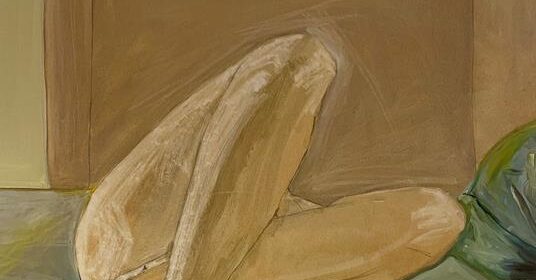
 Nei testi che analizza, in che misura il linguaggio usato per raccontare il parto tradisce una tensione tra l’esperienza vissuta e la sua rappresentazione simbolica? C’è una lingua possibile del parto, o è per sua natura indicibile?
Nei testi che analizza, in che misura il linguaggio usato per raccontare il parto tradisce una tensione tra l’esperienza vissuta e la sua rappresentazione simbolica? C’è una lingua possibile del parto, o è per sua natura indicibile?
