Michele Di Gerio, laureato in Medicina Veterinaria ed in Conservazione dei Beni Culturali -indirizzo Archeologico, area Classica, ha effettuato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ricerche su reperti ossei di specie animali da reddito rinvenuti negli scavi di Pompei. Ha condotto studi sugli strumenti chirurgici ritrovati negli scavi di Ercolano e Pompei. Nell’ambito delle ricerche riguardanti la figura del medico romano ha effettuato studi sulla pittura ‘Enea ferito’, rinvenuta negli scavi di Pompei. Col Dipartimento di Archeologia dell’Università di Colonia ha condotto ricerche su reperti ossei di specie animali e resti di molluschi del II-III secolo d.C. rinvenuti nelle ‘Terme romane’ di Baia. Presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” sta conducendo indagini su reperti ossei e dentali di cane rinvenuti negli scavi di Pompei. Le sue ricerche sono state pubblicate da Rivista di Studi Pompeiani e KuBA, rivista scientifica dei Dipartimenti di Archeologia delle Università di Colonia e Bonn. Tiene lezioni di Archeozoologia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha pubblicato tre saggi: La pesca nel Mediterraneo antico. I popoli, le specie acquatiche e l’economia (Guida Editori) nel 2016, Il cane nell’arte pompeiana (Valtrend Editore) nel 2017 e Archeologia e animali. La narrazione degli autori antichi (Guida Editori) nel 2019.
Le fonti che adopera sono le opere di autori di lingua greca e latina. Può indicarci la metodologia che ha adottato per orientarsi in un ambito tanto arduo ancorché insolito come il coniugare l’archeologia ed il mondo animale?
Poiché gli animali sono presenti in pitture, mosaici, bassorilievi e statue, è necessario, in un moderno contesto di ricerca archeologica, un loro studio approfondito che oltre a fornire dati anatomici, fisiologici, patologici e zootecnici, possa anche dare informazioni sul ruolo occupato nell’antichità in ambito sociale, economico e religioso. Per utilizzare le fonti classiche è stata necessaria da parte mia una buona conoscenza del contenuto delle opere di lingua greca e latina dove è presente la figura animale in ogni suo aspetto. Per il mio libro, Archeologia e animali. La narrazione degli autori antichi, ho consultato ventidue opere in lingua greca e ventisei in lingua latina. In alcune di esse le specie animali sono trattate ampiamente, ad esempio La caccia di Senofonte si occupa del cane da caccia con una serie di informazioni riguardanti l’addestramento, l’allevamento, l’alimentazione e l’accoppiamento mentre la Storia Naturale di Plinio il Vecchio, descrive molte specie animali, suddividendole in ‘terrestri’ e ‘acquatiche’, ed evidenziando gli aspetti biologici, economici e sociali, infine La natura degli animali, di Claudio Eliano è dedicata a tantissime specie, selvatiche e domestiche, la cui esposizione è simile a quella pliniana. Potrei citare altre opere dove l’animale è ampiamente trattato. Invece, in altre produzioni letterarie gli autori dedicano poco spazio agli animali anche se le informazioni fornite sono preziose. Per esempio, vorrei ricordare Le Metamorfosi di Apuleio dove è descritto l’asino utilizzato come forza-lavoro per azionare le macine del grano.
L’allevamento è una pratica intrapresa nel Neolitico. Quanto è stata determinante per il cambiamento della storia dell’uomo e, nella fattispecie, per le popolazioni affacciantesi sul Mediterraneo?
Prima dell’allevamento ci fu la domesticazione degli animali. I popoli primitivi giunsero alla domesticazione delle prime specie animali dopo moltissimo tempo perché il passaggio dalla pura e semplice cattura, espressa con la caccia, sino alla definitiva domesticazione, fu lenta e graduale. Con la domesticazione, l’animale abbandonò forzatamente le abitudini tipiche dello stato selvatico, integrando il proprio comportamento con quello dell’uomo. Fra le migliaia di specie di mammiferi esistenti, soltanto ben poche sono cadute sotto il dominio dell’uomo. Con la domesticazione l’animale fu allevato e utilizzato per la produzione di generi alimentari, utensili e come forza-lavoro nel settore agricolo. L’addomesticazione degli animali e il loro allevamento, insieme alla mietitura del grano selvatico e poi alla sua coltivazione, ebbero conseguenze sociali, come è facilmente immaginabile, di portata vastissima non soltanto sulle popolazioni del Mediterraneo antico ma anche nelle aree dell’entroterra orientale. Aumentando la quantità di cibo disponibile e legando contemporaneamente le comunità alle zone di produzione dello stesso cibo si registrò un costante incremento della popolazione. Questo processo, che segna il passaggio dal Mesolitico al Neolitico, fu definito ‘Rivoluzione Neolitica’ dal paletnologo inglese Vere Gordon Childe il cui segno più appariscente è la nascita del ‘villaggio’. Il carattere ‘rivoluzionario’ del passaggio è caratterizzato da una relativa rapidità e da un completo capovolgimento (si passa dal procacciamento alla produzione), con conseguenze culturali e demografiche enormi.
Può esemplificare il rapporto tra uomo ed animali domestici, ad esempio con gli animali d’affezione?
Con gli animali domestici da reddito l’uomo, sin dall’antichità, ha instaurato un rapporto soltanto per fini economici, che si è protratto senza alcun mutamento, sino in epoca moderna. Del bovino domestico utilizza il latte e le carni; del maiale, le carni e le setole, delle pecore, il latte e il vello; delle capre, il latte e le carni. Il cane e il gatto, invece, sono animali domestici d’affezione che dopo migliaia di anni, in modo diverso fra loro, si sono integrati nel nucleo familiare. Il gatto è presente nelle abitazioni ma continua ad assumere, rispetto al cane, un atteggiamento indipendente e austero. Il cane, invece, è completamente dipendente dall’uomo. Come in epoca antica continua ad assolvere compiti ben specifici: per la caccia, la compagnia e in alcune aree rurali è ancora impiegato per la guardia alla casa o delle pecore al pascolo. Vorrei ricordare che il particolare collare di epoca romana detto melium da Varrone, costituito da una striscia di cuoio dove erano posti dei chiodi protesi con la punta verso l’esterno, per proteggere il collo dei cani a guardia delle greggi di pecore dai morsi famelici dei lupi, è stato utilizzato, con la stessa funzione, sino a poco tempo fa dai pastori appenninici.
In qual misura gli animali hanno costituito nell’antichità classica una fonte di reddito?
In misura rilevante perché il settore zootecnico, insieme a quello agricolo, costituiva una notevole fonte di reddito. Riferito ai primi secoli della storia di Roma l’allevamento animale era largamente praticato da piccoli allevatori, con poche decine di animali, solitamente di una stessa specie. Dal 202 a.C., anno della disfatta annibalica, si assiste alla trasformazione delle fattorie di epoca medio-repubblicana in villae grazie al flusso di nuovi capitali e a un elevato di numero di schiavi impiegati come forza-lavoro. Nella villa, che occupa una certa centralità nell’economia romana, diviene fiorente non soltanto l’attività agricola ma anche l’allevamento animale. In tale struttura vengono allevate molte centinaia di animali da reddito di diversa specie. Imperatori, personaggi della politica o anche diversi letterati, tra questi Orazio, erano proprietari di villae che garantivano ricchezza. Ma anche nei piccoli centri o nelle aree periferiche dell’impero, i politici e i personaggi dell’aristocrazia locale erano proprietari di villae. Catone il Censore, Varrone e Columella nelle loro opere descrivono, oltre al settore agricolo, anche l’allevamento animale con interessanti informazioni zootecniche e medico veterinarie ampiamente utilizzate da me e da altri studiosi nel corso delle nostre ricerche.
I popoli antichi hanno attribuito un valore sacro agli animali, reputandoli imperscrutabili e divini. Ci offrirebbe qualche scenario curioso?
Mi sembra curioso, ma di importanza sociale, un fatto riguardante la sacralità del gatto nell’antico Egitto. Erodoto fu il primo autore ad interessarsi in modo approfondito al culto del gatto ed alla dea Bastet. Secondo la narrazione dello storiografo chiunque uccideva volontariamente un gatto veniva messo a morte, se invece, involontariamente pagava una multa imposta dai sacerdoti. Diodoro Siculo conferma e rafforza l’informazione di Erodoto. Infatti, dall’autore sappiamo che chiunque avesse ucciso involontariamente o volontariamente, un gatto o un ibis, era condannato a morte. Egli fu testimone di un singolare evento. Un membro della delegazione romana in visita in Egitto uccise accidentalmente un gatto, e secondo le leggi vigenti non fu possibile alcun sconto della pena capitale neanche se l’avesse voluto il re in persona. Ma spesso era il popolo ad uccidere il colpevole senza aspettare alcuna sentenza. La folla accorse presso la casa del membro della delegazione romana per ucciderlo ma i magistrati, mandati dal re, ebbero il potere di sottrarre l’uomo alla terribile punizione popolare. Egli, comunque, non fu ucciso neanche successivamente.
Giuseppina Capone



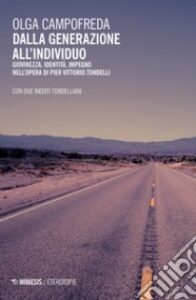

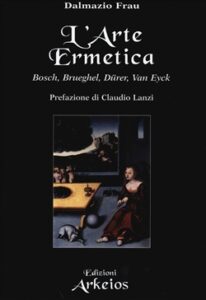 Con un andamento dicotomico lei contrappone Eterno e Contemporaneo: non ravvede possibilità di sincretismo?
Con un andamento dicotomico lei contrappone Eterno e Contemporaneo: non ravvede possibilità di sincretismo?
 Il percorso della protagonista si dipana anche a ritroso nel tempo; si serve di ricordi ingialliti e via via emergenti. La sua personale indagine adopera flashback che compongono un puzzle di notevole suspense. Quale valore attribuisce all’elemento della “memoria” nella sua produzione? Si possono davvero chiudere i conti con il passato?
Il percorso della protagonista si dipana anche a ritroso nel tempo; si serve di ricordi ingialliti e via via emergenti. La sua personale indagine adopera flashback che compongono un puzzle di notevole suspense. Quale valore attribuisce all’elemento della “memoria” nella sua produzione? Si possono davvero chiudere i conti con il passato?
 Fughe intenzionali, amori inammissibili, piccole ossessioni, flirt goffi, mestizie fulminee, inerzia dell’esistenza, desideri latenti, lontananze subìte e cercate, famiglie sguaiate e complesse, ricerca di inediti equilibri e nuove identità. Molteplici e plurimi temi per un romanzo corale. Può motivare la scelta della polifonia?
Fughe intenzionali, amori inammissibili, piccole ossessioni, flirt goffi, mestizie fulminee, inerzia dell’esistenza, desideri latenti, lontananze subìte e cercate, famiglie sguaiate e complesse, ricerca di inediti equilibri e nuove identità. Molteplici e plurimi temi per un romanzo corale. Può motivare la scelta della polifonia?





