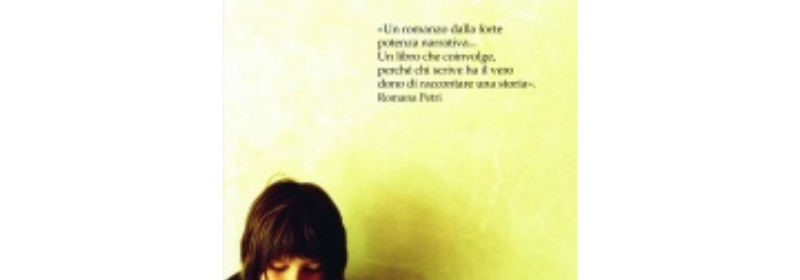Le atmosfere forti di Palazzokimbo, si realizzano con una insolita e preziosa cadenza dei casi letterari che, per la speciale combinazione fra il contesto ambientale, la trama contemporanea incardinata in avvenimenti realmente accaduti con le comparse di noti personaggi pubblici protagonisti della storia repubblicana italiana (un romanzo storico o di formazione secondo la vulgata corrente), integrati in una speciale potenza narrativa; raggiungono un rapporto di intima condivisione fra la voce narrante dell’autore e l’ascolto orante del lettore. Conquistano una sovrapposizione di comuni esperienze e nitidi ricordi quasi perfetta, una osmosi impressionante fra i diversi stati d’animo come se il testo esprimesse una rappresentazione tridimensionale, interattiva. Capace d’includere lo stesso lettore nello scorrere delle pagine con una sorta di magica macchina del tempo che simuli con straordinaria resa una trasposizione fisica e sensoriale.
Si prova questo e altro vivendo le atmosfere forti di “Palazzokimbo”, romanzo finalista al Premio Neri Pozza 2015 scritto da Piera Ventre, edito dalla omonima casa editrice nell’autunno dello scorso anno. Napoletana d’origine l’autrice vive e lavora a Livorno sin dal 1987 come logopedista e assistente alla comunicazione nei progetti dedicati al “mondo della sordità” realizzati con l’Associazione Comunico. La sua passione per la scrittura, sin dalla prima infanzia, trova un riscontro importante nel 2015, quando su 1293 candidati si classifica al terzo posto con questa perla nel concorso letterario bandito da Neri Pozza.
Raggiungiamo l’Autrice in un breve intervallo della sua lunga giornata lavorativa.
Il suo primo romanzo esprime uno spaccato storico del nostro passato recente ambientato nella Napoli operaia di fine Novecento. Quanto incide in questo testo la cultura del suo vissuto privato?
“Palazzokimbo” è un luogo fisico, realmente esistito, situato a Napoli Est, nella periferia industriale della città. E’ in quel palazzo, abitato per lo più da operai della Saint Gobain e dalle loro famiglie, che ho vissuto la mia infanzia. Entrambi i miei genitori sono stati operai: mio padre in vetreria e mia madre in una fabbrica di vernici. Volevo partire da un dato autobiografico che mi permettesse di parlare di una realtà che rischia di scomparire: quella del ceto operaio napoletano, ricco di relazioni solidali e di dignità. Il romanzo inizia nel 1973, quando a Napoli scoppiò lo scandalo del Colera e termina nel 1980, col terremoto dell’Irpinia, due avvenimenti che segnarono la città in modo indelebile. Nel mezzo, si dipana la Storia di quel decennio difficile per l’Italia intera. Sono stati quelli gli anni della mia formazione. Ho attinto a tutto ciò cercando di rendere vero il verosimile dei personaggi che compongono il romanzo. Nell’invenzione letteraria di ciascuno di essi c’è sicuramente un frammento di me. Del resto è questa l’alchimia che opera la scrittura: partire da una vicinanza per discostarsene e tramutarla in altro.
La narrativa potente, i contrasti forti estrapolati in un contesto popolare dove bene e male sono valori distinti, contaminati in un perbenismo piccolo borghese, mostrano una scrittura adulta e di spessore, tipica di un blasone con tanti successi alle spalle. Come spiega questa lunga gestazione per un primo esordio sulla ribalta editoriale nazionale?
“Scrivere è cercare la calma e qualche volta trovarla. È tornare a casa”, disse Anna Maria Ortese, una scrittrice che amo moltissimo, in un’intervista. Palazzokimbo ha una genesi lontana e si è organizzato in una forma che possiamo definire “romanzo” attraverso stratificazioni alternate a potature in un tempo lungo. Probabilmente tutte le volte che mi sedevo alla scrivania cercavo di tornare un poco “a casa”. Sono stata la prima ad accordarmi lentezza. L’ho inviato in lettura solo quando ho compreso che era arrivato il momento del distacco. La scrittura l’ho allenata nei racconti, che sono stati pubblicati in raccolta da Erasmo, una piccola casa editrice di Livorno e tenendo diari fin da bambina. Sono convinta che, alla fine, le cose accadono quando arriva il momento che debbano accadere. E che la scrittura sia un processo in divenire, che ha bisogno di una buona dose di umiltà.
Diversamente da alcuni suoi colleghi scrittori, le storie che narra, non derivano in modo evidente dalle tematiche che affronta nella sua professione. Quali sono i bisogni prioritari che la inducono a scrivere un romanzo o dei saggi da pubblicare?
Non escludo di scrivere, prima o poi, qualcosa che attinga alla mia esperienza di educatrice e logopedista. Ma non ho risposte esatte riguardo al meccanismo dell’argomento narrativo. L’unica cosa della quale ho certezza è che necessito di un coinvolgimento emotivo rispetto a ciò che intendo raccontare. Devo percepire un’urgenza per avere la necessità di passare tante ore al chiuso, davanti a uno schermo. In caso contrario sentirei di esercitare esclusivamente un mero esercizio di stile. E, se così fosse, ci sarebbero così tante cose da fare per occupare meglio il tempo, non trova? Il tempo è l’unica cosa preziosa di cui dovremmo imparare a disporre con rispetto.
Da molti anni vive a Livorno. In comune con la sua città d’origine probabilmente c’è solo il mare, il porto e probabilmente la presenza di molti conterranei che hanno lasciato il golfo reale per motivi di lavoro. Cosa vorrebbe portare sempre con sé della cultura napoletana, a Livorno come in altri luoghi italiani?
Non sono una napoletana nostalgica, tuttavia so che essere nata a Napoli, e averci vissuto gli anni che indubbiamente sono formativi nel processo di crescita, mi ha portato ad essere ciò che ora sono, sebbene il fatto di essermene allontanata mi spinga a definirmi “napòlide”, per dirla alla Erri De Luca, e a non riconoscermi più né a Livorno né nella mia città d’origine. Credo, però, che ogni luogo abbia la capacità di plasmare il nostro sguardo sul mondo in maniera esclusiva. Ed è questo che porto con me di Napoli: il modo che la città mi ha insegnato a guardarmi attorno. Non saprei dirlo diversamente.
Nella nostra società contemporanea, preda di tante criticità e paure, quale sentimento espresso in Palazzokimbo riterrebbe indispensabile, di quale personaggio sente la maggiore mancanza?
Innanzitutto la dignità dei due genitori di Stella e di tutti gli abitanti del palazzo. Poi la forza della madre, la sua capacità di resistenza, di rimboccarsi le maniche e di battere i coperchi di fronte ai soprusi della vita. Infine, lo sguardo “marginale” di Stella, quel suo desiderio di cercare il bello anche nella desolazione, l’albero stento che cresce ai bordi dell’autostrada che le dice che, a ben guardare, un ritaglio di speranza è la sola opportunità che possiamo darci per cercare di essere persone migliori. È proprio Stella è il personaggio che mi manca di più, il suo mettersi in un angolo per riuscire a vedere le cose da un’ottica decentrata, da una prospettiva periferica. Oggi, assieme a paure e criticità, assistiamo a una smania di protagonismo che rischia di snaturare la visione del mondo in cambio di una miopia egocentrica, che può sfociare in un individualismo cannibale. Allargare lo sguardo, spostarsi dal “centro”, ci fa vedere l’altro. Ed è quello che Stella prova a fare.
Il 30° Salone del Libro di Torino è una edizione molto attesa e discussa dopo le recenti evoluzioni del mercato editoriale nazionale che hanno acceso nuovi riflettori su altre piazze con nuovi soggetti, Milano e la Nave di Teseo per non fare nomi. Cosa prova una amante artigiana delle parole come lei rispetto a queste dinamiche?
Credo che non sia utile avere questa sorta di “dispersione di energie”. Sarebbe stato meglio puntare su un evento unico, convergere tutte le risorse per potenziarlo al pari di altre Fiere Internazionali, e io, al Salone del libro di Torino, sono affezionata. In quanto alle dinamiche editoriali, queste dovrebbero essere volte, piuttosto, a portare alla luce una buona letteratura, a condurre il lettore alla qualità. Gli editori, insomma, dovrebbero riappropriarsi del ruolo che ben hanno ricoperto nel passato e porsi domande importanti rispetto a ciò che vorrebbero porgere ai lettori. Temo che però i libri si stiano trasformando per lo più in “prodotti” e, attorno a essi, ci sia un proliferare di spettacolarizzazione un po’ svilente. Non ho grande esperienza rispetto a questo. Ciò che dovrebbe fare uno scrittore è mettere le proprie energie, il proprio cuore e la propria onestà in ciò che scrive, occuparsi di questo, sostanzialmente. “Cercare la calma, e qualche volta trovarla”.
Luigi Coppola

 A San Giorgio a Cremano intitolata la biblioteca comunale di Villa Bruno al sacerdote Giovanni Alagi, storico ed autore di svariate pubblicazioni sulla città, come “Bernardo Tanucci a San Giorgio a Cremano, “In breve…”, “Salvatore Punzo e i suoi tempi”, “Il cardinal Massaia a San Giorgio a Cremano”, “La processione di San Giorgio a Cremano” o “La chiesa di San Giorgio vecchio e il cimitero comunale”.
A San Giorgio a Cremano intitolata la biblioteca comunale di Villa Bruno al sacerdote Giovanni Alagi, storico ed autore di svariate pubblicazioni sulla città, come “Bernardo Tanucci a San Giorgio a Cremano, “In breve…”, “Salvatore Punzo e i suoi tempi”, “Il cardinal Massaia a San Giorgio a Cremano”, “La processione di San Giorgio a Cremano” o “La chiesa di San Giorgio vecchio e il cimitero comunale”.