Professor Marino, Theodor W. Adorno è un esponente di spicco della teoria della critica della società legata alla Scuola di Francoforte. Ebbene, quale ruolo ha giocato il confronto con l’industria culturale e con l’esperienza estetica che la caratterizza?
Per prima cosa, ci tengo a esprimere un sincero ringraziamento per il suo interesse per il mio lavoro filosofico: è una cosa che apprezzo molto, che non va mai data per scontata, e per la quale dunque la ringrazio. Poi, rispondendo alla sua domanda, direi che, a differenza di quanto si tende spesso a credere, quello che lei ha appropriatamente chiamato il confronto con l’industria culturale e con l’esperienza estetica che la caratterizza ha giocato un ruolo molto importante (e, quindi, niente affatto trascurabile o “secondario” rispetto ad altre occupazioni tipicamente considerate “primarie” o più serie) all’interno dell’itinerario di pensiero di Adorno come filosofo, sociologo e musicologo – dato che il pensatore francofortese, com’è noto, sapeva coniugare e intrecciare fra loro queste tre dimensioni della sua attività di teorico critico della società. In altre parole, in base all’interpretazione che ho offerto nel mio ultimo libro (Verità e non-verità del popular. Saggio su Adorno, dimensione estetica e critica della società, 2021), nel momento in cui Adorno dedica il proprio tempo e le proprie energie alla stesura di saggi come Sulla situazione sociale della musica (1932), Sul jazz (1936), Il carattere di feticcio della musica e la regressione nell’ascolto (1938) e 16 (1941), non concepisce questa attività di confronto con la musica leggera e la sua fruizione spesso distratta come una “distrazione” rispetto ad attività a prima vista più serie e importanti come la decifrazione filosofico-sociologica della musica d’avanguardia di Schönberg, Berg, Webern e Stravinskij, alla quale non a caso si dedica con attenzione e passione esattamente negli stessi anni. Se, come scrive Adorno in modo molto enfatico nel suo capolavoro di “musicologia filosofica”, Filosofia della musica moderna (1949), “le forme dell’arte registrano la storia dell’umanità più esattamente dei documenti”, ciò implica, per il teorico critico che voglia sviluppare una teoria estetica davvero completa e adeguata (come Adorno cercherà di fare fino alla fine della sua vita, approdando all’incompiuta e postuma Teoria estetica uscita nel 1970), di confrontarsi seriamente con entrambe le sfere della cultura, ovvero sia quella “seria” che quella “leggera”, intese da Adorno come “le due metà, strappate l’una dall’altra, della libertà integrale, che però non si lascia ridurre alla loro mera somma” (lettera di Adorno a Benjamin del 18 marzo 1936). Naturalmente, ciò non toglie che nella stragrande maggioranza dei casi, a partire dai saggi dei primi anni Trenta per arrivare all’Introduzione alla sociologia della musica (1962) e altri scritti, il confronto di Adorno con la popular music, l’industria culturale e l’esperienza estetica che la caratterizza, sia stato un confronto critico, spesso molto duro e talvolta, a mio avviso, persino un po’ eccessivo nella riconduzione di tutta la musica leggera a un’implacabile standardizzazione. Tuttavia, ciò non toglie in alcun modo che gli strumenti analitici e concettuali forniti da Adorno per un’analisi della cultura popular in chiave di teoria critica della società siano ancora molto preziosi e utili, per non dire in alcuni casi indispensabili, soprattutto ai fini di una comprensione non meramente acritico-descrittiva, bensì critico-normativa, di tali fenomeni.
Il pensiero di Adorno possiede una natura dinamica, aperta e plurale volta ad investigare la tematica della verità del non-vero e della non-verità che spesso inerisce al vero. Quali riflessioni scaturiscono dal confronto critico con la popular music novecentesca?
In primo luogo, come ho cercato di mostrare nel mio precedente libro (Le verità del non-vero. Tre studi su Adorno, teoria critica ed estetica, 2019), nonostante Adorno, a differenza di molti altri filosofi a lui contemporanei, non abbia mai scritto un’opera specificamente dedicata al tema della verità in quanto tale, cionondimeno questa tematica è fortemente presente nella sua opera a tutti i livelli, cioè ad esempio a livello sia filosofico che sociologico che musicologico. Inoltre, in un modo che è caratteristico in generale del suo approccio dialettico al pensiero, tale tematica è presente in Adorno soprattutto nella forma di un’indagine sull’intreccio di verità e non-verità: “la filosofia si attua come tale nella permanente disgiunzione del vero e del falso”, scrive Adorno nei Tre studi su Hegel (1963), ma sempre con la consapevolezza che un certo fenomeno o evento (filosofico, musicale, sociale, culturale, storico), anche quando è dotato di ciò che egli chiamava “contenuto di verità”, non per questo può considerarsi del tutto esente da tratti di non-verità se osservato da una prospettiva più ampia e approfondita. Nel mio libro del 2019 ho provato a verificare la portata di questa idea soprattutto tramite un’analisi delle interpretazioni critiche di Adorno della filosofia di autori come Kant, Hegel, Nietzsche e Spengler, nonché della musica di Stravinskij, laddove nel mio libro del 2021 il tema del rapporto dialettico fra vero e non-vero è stato messo alla prova sul terreno della cultura di massa, con un focus specifico sulla popular music (intesa come musica “leggera”, “di massa” e “di consumo”, più che come musica “popolare” nel senso del richiamo alle tradizioni popolari). Per rispondere quindi alla seconda parte della sua domanda, direi che, in primo luogo, è sempre bene tenere presente che oggi, nel 2021, quando leggiamo i saggi di Adorno sul jazz, la popular music, il feticismo in musica e la regressione dell’ascolto, le nostre fonti sonore e i nostri riferimenti musicali e culturali sono parzialmente (sebbene non per forza interamente) diversi da quelli di Adorno. Ciò è stato oggetto di studi specifici, spesso molto accurati a livello storiografico-musicale, fra i quali mi limito a citare quelli di J. Bradford Robinson, R. Leppert, M. Paddison e altri ancora. Solo sulla base di questo dato di fatto, relativo alla formazione di Adorno sia a contatto con le poetiche d’avanguardia primo-novecentesche, sia a contatto con un certo “pseudo-jazz” tedesco degli anni ’20-’30 e poi con un certo jazz ballabile negli U.S.A. negli anni ’30-’40, si spiegano alcune posizioni molto critiche del filosofo di Francoforte nei confronti di tutta la popular music (compreso tutto il jazz), talvolta chiaramente denotanti un’incomprensione verso certi fenomeni, nonché una mancanza di feeling per l’improvvisazione e altro ancora. D’altra parte, ciò non toglie che, anche qualora vengano applicate alla comprensione di fenomeni musicali più recenti, molte categorie introdotte da Adorno nella sua “musicologia filosofica” (come le categorie di standardizzazione e pseudo-individualizzazione, nel caso della sua teoria della popular music) rivelino ancora oggi una straordinaria pregnanza, attualità e capacità di dischiudere nuovi orizzonti interpretativi, soprattutto se ripensate, rimodellate a contatto con fenomeni diversi da quelli a lui noti, e se adottate con flessibilità anziché con rigidità. Sia i saggi dei miei colleghi Alessandro Alfieri, Colin Campbell, Giacomo Fronzi e Marco Maurizi raccolti nel libro Adorno and Popular Music che ho curato nel 2019, sia le analisi che ho svolto con la mia tesista Eleonora Guzzi nel libro La filosofia dei Radiohead (2021), vanno un po’ in questa direzione.
Lei, talvolta, marcia contro Adorno, analizzando i rapporti tra arte e società. Quale potenziale politico possiede, a suo avviso, la popular culture?
Come dicevo, la scelta, in diversi miei articoli e libri recenti, di approcciare la popular culture con gli strumenti di una teoria estetica, come quella di Adorno, declinata in chiave di teoria critica della società, deriva dalla convinzione che perlomeno alcuni fra i numerosi strumenti di analisi forniti a suo tempo da questo autore conservino ancora oggi una straordinaria capacità di penetrazione intellettuale nel campo di questi fenomeni. Chiaramente, però, tutto ciò è valido solo a patto di non assumere un atteggiamento di adesione immediata e acritica nei confronti di ciò che Adorno ha pensato e scritto (perlopiù in modo pessimistico e polemico, com’è noto) a proposito dell’industria culturale e della popular music, bensì di assumere un atteggiamento vigile e critico nei confronti delle sue stesse categorie interpretative. A mio avviso, del resto, ciò è altrettanto vero nel caso dello studio del pensiero di altri autori o altre autrici, nel senso che se c’è una cosa che in filosofia non andrebbe mai fatta, questa è proprio l’adozione di un atteggiamento acritico o persino dogmatico nei confronti della dottrina filosofica che si sta studiando e approfondendo: la filosofia va sempre studiata in modo critico, seppure a partire da un senso di grande rispetto (e talvolta persino di gratitudine) nei confronti dell’autore o l’autrice con cui ci si confronta, e dunque evitando assolutamente che ciò che sto provando a definire in termini di atteggiamento o approccio critico degeneri in presunzione, arroganza e sciocca hybris intellettuale. Detto altrimenti, se mi occupo del pensiero di Kant, che è per certi versi il filosofo critico par excellence, è bene che io lo faccia essendo animato da un sano e magari anche intransigente atteggiamento critico nei confronti del suo stesso criticismo, ma senza mai perdere l’umiltà e la ragionevolezza di riconoscere che, in ogni caso, il mio autore è il grande Immanuel Kant e io, anche qualora scorgessi delle “fratture” (come amava chiamarle Adorno) nel suo sistema, in confronto a lui rimango comunque un piccolo Stefano Marino. Tornando alla sua domanda, in alcuni miei contributi recenti su Adorno mi sono servito a volte per comodità di formule sintetiche (e indubbiamente un po’ semplificative, ma dotate in compenso del pregio della chiarezza) come “approccio adorniano ortodosso/eterodosso” per indicare l’atteggiamento metodologico e interpretativo che sto provando qui a chiarire. Anche in Verità e non-verità del popular ho cercato di mantenermi fedele a tali presupposti nell’approcciare i fenomeni dell’industria culturale e della popular music, procedendo quindi “con Adorno” e però, ove necessario, al contempo anche “contro Adorno”. Da un lato, dunque, si tratta di accostarsi ad Adorno (così come al pensiero di qualsiasi altro pensatore o altra pensatrice, come dicevo) in modo critico, cioè senza fargli sconti, senza lasciarsi condizionare dalla sua indiscutibile autorità in campo filosofico e musicale, e senza privarsi della libertà di mettere in luce ambiguità o problematicità presenti nella sua prospettiva interpretativa, là dove queste ultime emergano; dall’altro lato, però, si tratta di riconoscere al contempo il carattere raro e talvolta unico delle sue analisi dei fenomeni culturali (compresi quelli musicali e, fra questi ultimi, inclusi anche quelli popular). Sotto questo punto di vista, da un lato ritengo legittima in linea di principio qualsiasi obiezione e disamina critica rivolta al pensiero di Adorno, anche sul terreno della sua polemica corrosiva nei confronti della popular culture, purché supportata da valide ragioni e argomentazioni; dall’altro lato, ritengo al contempo che sia un grave errore far sfociare le obiezioni alla critica adorniana della cultura di massa in versioni stereotipate o persino caricaturali del pensiero di Adorno, come purtroppo è capitato spesso e forse continua ancora oggi ad accadere. Fra questi due poli, sintetizzati col ricorso ai semplici termini “con” e “contro”, si è sviluppato negli ultimi anni il mio confronto con la riflessione adorniana, ovvero in uno spazio definito da un atteggiamento di adesione ragionata e condizionata (e dunque mai aprioristica o incondizionata) e di critica articolata e argomentata (e dunque mai banalmente distruttiva e fine a se stessa, ma auspicabilmente costruttiva). Quanto alla questione del potenziale politico insito nella dimensione estetica, compresa l’esperienza estetica spesso “distratta” e immersa nella quotidianità della popular culture, credo la questione sia enorme e di grandissimo interesse anche per l’influenza e l’impatto che la cultura di massa può avere sulle nostre idee, valutazioni e scelte a tanti livelli, non escluso quello etico e politico. A tal proposito, in riferimento ai pensatori francofortesi direi che ciò che possiamo imparare di davvero importante dalle riflessioni di Adorno e anche di Marcuse è come spesso la cosiddetta questione dell’“impegno”, in campo artistico (compreso il caso di una canzone pop-rock), sia più una questione di sperimentazione sul piano della struttura e della forma che una questione di trasmissione immediata di un contenuto o messaggio “politicizzato”. Una prospettiva di questo tipo, infatti, dischiude orizzonti molto interessanti ai fini di un’interpretazione non banalizzante o immediata, ma viceversa mediata e attenta a sfumature e dettagli spesso meno percettibili ma comunque presenti nelle opere d’arte o nelle performance: la lettura delle esecuzioni femminili di brani della tradizione blues che è stata offerta dalla celebre teorica femminista Angela Davis (che, da giovane, fu allieva diretta di Marcuse) rappresenta in tal senso un valido esempio di uno sviluppo ulteriore della succitata prospettiva interpretativa, come ho potuto apprendere recentemente dalla tesi di una mia studentessa, Ines Zampaglione (giacché, sì, a volte sono i/le docenti a imparare dai lavori dei propri studenti e delle proprie studentesse!). In riferimento ad altri autori o autrici che hanno elaborato la questione del rapporto fra dimensione estetica e potenziale politico sulla base di altre categorie di riferimento e all’interno di altre tradizioni filosofiche, direi che, nel caso di arti particolarmente legate alla dimensione performativa, un grande ruolo sia svolto anche dalla componente somatica, cioè dall’uso del corpo del/della performer (compreso il/la musicista rock) allo scopo di veicolare certi significati a livello sia formale che contenutistico; a tal riguardo, la riflessione recente di un filosofo pragmatista come Richard Shusterman può offrire stimoli estremamente interessanti e originali.
Musica e moda possono rivelarsi armi subdole e infide, in grado di sollecitare i più imprevedibili esotismi e razzismi?
Così, su due piedi, e in modo molto spontaneo, mi verrebbe da rispondere a questa domanda che la musica o la moda (così come, in generale, anche l’arte, la filosofia, la politica, lo sport e forse ogni altra cosa) sono un po’ come l’amore, cioè qualcosa che, a seconda delle circostanze, del contesto, delle persone coinvolte, del momento particolare della tua vita ecc., può rappresentare sia una salvezza, sia viceversa una rovina. Come canta Sting con i Police, “love can mend your life” ma, al contempo, “love can break your heart”; come canta Chris Cornell con i Temple of the Dog e i Soundgarden, “love heals all wounds with time” ma, al contempo, a volte “love’s like suicide”. Come si domanda il protagonista di Love, il controverso film di Gaspar Noé del 2015: “Love is strange. How can something so wonderful bring such great pain?”. Ecco, al di là del paragone con l’amore (che, come dicevo, mi è venuto in mente in modo spontaneo e che, essendo piuttosto sensibile a questo tema, ho voluto concedermi di citare), direi che, mutatis mutandis, oscillazioni di tipo analogo possono verificarsi più o meno in ogni esperienza umana. Nessuna pratica umana ne è esente a priori, nessuna è garantita in linea di principio dal capovolgersi nel suo opposto, cioè dal rovesciarsi in ciò che, a prima vista, non tenderemmo ad associare a essa. Ciò (o chi) ha la funzione di educare, a volte può rivelarsi diseducativo; ciò (o chi) ha il ruolo di sgomberare il campo dai pregiudizi, a volte può rivelarsi prigioniero e portavoce di altri stereotipi e preconcetti; ciò (o chi) può apparire in prima battuta come dotato di una funzione progressiva, a volte può rivelare in seconda battuta tratti regressivi; ciò (o chi) suscita in noi l’aspettativa di aprire nuovi orizzonti che favoriscano dialogo e comprensione reciproca, può impercettibilmente ma fatalmente (e a volte inconsapevolmente) scivolare verso nuove forme di chiusura e discriminazione, compreso, nei casi più gravi, il razzismo da lei citato (o il sessismo, aggiungerei). Mi torna in mente, a tal proposito, un passaggio tratto da Prismi, là dove Adorno avverte che non basta semplicemente “diffamare la barbarie e confidare nella salute della civiltà”, ma piuttosto, in modo meno ingenuo e più disincantato, si deve cogliere “l’elemento di barbarie che pervade la stessa civiltà”, cioè bisogna osare sfidare “l’idea di civiltà non meno che la realtà della barbarie”. Ora, proprio perché il significato e la funzione di un’opera, di un’esperienza, di un evento, di un fenomeno storico-culturale o anche semplicemente di una parola o un’azione non sono garantiti una volta per tutte, ma possono talvolta paradossalmente capovolgersi nel proprio opposto (in virtù del contesto, delle situazioni contingenti o anche, per dirla con Gadamer, di una certa “storia degli effetti”), rimane valido il lucido avvertimento contenuto in un brano magnifico dei C.S.I. di Giovanni Lindo Ferretti: “Occorre essere attenti per essere padroni di se stessi / Occorre essere attenti”. Tutto ciò, però, stando attenti al contempo a non essere troppo attenti (!), ovvero prestando sempre attenzione al fatto che lucidità, serietà e padronanza di sé non soffochino la propria spontaneità, e al fatto che il disincanto (che così bene e così giustamente si sposa alla lucidità e all’attenzione) non privi del tutto di una componente di incanto e anche di ingenuità la nostra esperienza con il mondo e la nostra interazione con le altre persone. Comunque, al di là di queste mie osservazioni di carattere un po’ generale, quanto ai punti specifici e particolari toccati dalla sua domanda (che citano moda, musica e razzismo), vorrei solo aggiungere due cose. Primo, che in tempi recenti anche la filosofia della moda (al pari dell’estetica della popular music, del design, del cinema e di molte altre pratiche non contemplate dall’estetica tradizionale nel senso ristretto di “filosofia delle belle arti” e della cosiddetta “grande arte”) ha avuto un significativo riconoscimento e sviluppo, come testimoniato dai lavori di autori come Nickolas Pappas, Lars Svendsen e altri: per chi fosse interessato/a, mi permetto di rimandare in tal senso al libro Philosophical Perspectives on Fashion che curai anni fa con Giovanni Matteucci per l’editore Bloomsbury. Secondo, che proprio Adorno è stato accusato talvolta di razzismo per via dei suoi giudizi estremamente critici sul jazz, in parte dovuti alla sua scarsa comprensione del senso dell’improvvisazione musicale e alla sua conoscenza solo parziale della cultura musicale afro-americana; tuttavia, se, come dicevo, è senz’altro lecito e anzi opportuno studiare Adorno (come ogni autore e autrice) in modo critico, nel caso di un’obiezione del genere ci si trova di fronte a un fraintendimento grossolano e anche pericoloso, di cui peraltro si accorse già negli anni Cinquanta lo stesso Adorno, il quale infatti nel breve testo Replica a una critica a “Moda senza tempo” (incluso nella raccolta Variazioni sul jazz. Critica della musica come merce, edita nel 2018) scrisse: “proteggere i neri proprio dalla mia arroganza bianca – quella di uno che è stato cacciato da Hitler – è grottesco. Piuttosto, per quel che permettono le mie deboli forze vorrei difendere i neri dall’umiliazione di cui sono vittima quando si abusa della loro capacità espressiva trasformandola nella prestazione di un clown eccentrico. Che tra i fan [del jazz] vi siano sinceri contestatori, bramosi di libertà, lo so: il mio saggio menziona il fatto che ‘l’eccessivo, il non-sottomesso nel jazz […] viene ancora sentito insieme a esso’. […] Ma credo che il loro anelito, forse a causa dell’ignobile privilegio culturale in campo musicale che domina nel mondo, sia sviato verso una falsa primordialità e pilotato autoritariamente”.
Professore, qual è oggidì la funzione della cultura?
La sua domanda è quanto mai ampia e ambiziosa, e dunque non è facile fornire una risposta univoca e sintetica. Ciò, in primo luogo, per via del semplice ma evidente fatto che il concetto stesso di “cultura”, al pari di altri concetti di pari ampiezza, complessità e profondità (come, ad esempio, “arte”, “storia”, “scienza”, “filosofia”, “gusto”, “giudizio”, per non parlare poi di “essere”, “divenire”, “spirito”, “verità”, ecc.), non ha un’unica definizione ma, al contrario, può essere (e, di fatto, è stato) definito in modi diversi, a seconda dei presupposti teorici di partenza, degli scopi finali della riflessione e di molto altro ancora. Come scrive Dick Hebdige in apertura a un libro importante e influente come Sottocultura: “la cultura […] è un concetto notoriamente ambiguo. Rifratta in secoli d’uso, la parola ha acquisito una serie di significati assai differenti e spesso contrastanti fra loro”. Detto ciò, comunque, e tenendo conto del senso e del contesto specifico del discorso sviluppato in questo colloquio (ovvero, un contesto di teoria critica e incentrato sul rapporto fra vero e non-vero, intesi adornianamente come rappresentativi, rispettivamente, di un rapporto critico-negativo o, viceversa, acritico-affermativo verso il reale), le risponderei che, come si legge in Dialettica dell’illuminismo, “la cultura è una merce paradossale”, nel senso che, da un lato, perlomeno a partire dalla tarda modernità e la successiva estetica del pop (con la celebre definizione dell’arte come “prostituzione” da parte di Baudelaire e, un secolo dopo, la non meno celebre e provocatoria aspirazione di Warhol a trasformare definitivamente l’arte in un business), essa non può fare a meno di constatare l’avvento della mercificazione anche al proprio interno, ma dall’altro lato, e al contempo, la vera cultura non può neanche fare a meno di interrogarsi criticamente su stessa e tentare di mettere anche solo parzialmente in discussione lo stato di cose presente o, con una terminologia più francofortese, l’esistente. Nel caso specifico di quel particolare prodotto culturale che è un’opera d’arte, in Teoria estetica Adorno spiega che l’opera d’arte, sottoposta oggi alla mercificazione e al feticismo, è tenuta a fare i conti con tali processi, incorporarli in sé e trascenderli immanentemente per configurarsi alla fine come una cosa che sa spogliarsi della propria cosalità, come una sorta di merce che è capace di trascendere se stessa. Scrive Adorno: “nell’apparenza estetica l’opera d’arte prende posizione nei confronti della realtà, che essa nega diventando una realtà sui generis. L’arte fa obiezione alla realtà con la propria obiettivazione. […] Nel pieno dell’utilità dominante l’arte [è] l’altro, ciò che è esente dal meccanismo del processo di produzione e riproduzione della società, ciò che non è sottoposto al principio di realtà”. Una tale dinamica, eminentemente dialettica e in qualche modo anche paradossale, viene talvolta esemplificata da Adorno col riferimento al “gesto del barone di Münchhausen, che si solleva dallo stagno afferrandosi per il codino” (Minima moralia, §46). Oltre a ciò, tornando alla questione più generale del significato della cultura oggi, mi piace concludere la mia risposta alla sua domanda con un rimando all’idea di una perdurante e ancora valida (nonostante tutto) funzione critica della cultura, cioè di una capacità e, in un certo senso, una necessità, da parte della cultura, di favorire l’elaborazione e lo sviluppo di un atteggiamento critico (e, per questo motivo, attivo, anziché rassegnato, sottomesso e passivo) verso il reale. In un recente contributo filosofico-politico sulla pandemia (in uscita a inizio 2022 in un volume da me curato dal titolo Estetica, tecnica, politica: immagini critiche del contemporaneo), la mia collega Valentina Antoniol ha richiamato l’attenzione sulla definizione foucaultiana della filosofia come “superficie d’emergenza di un’attualità” di cui proporre “un’ontologia”, dunque come un’ontologia dell’attualità che è anche “un’ontologia critica di noi stessi”. Pur non essendo possibile, ovviamente, sovrapporre sic et simpliciter la prospettiva critica di Foucault a quella di Adorno, una definizione di questo tipo della filosofia (e, in senso più ampio, del sapere e della cultura come “strumenti” per prendere posizione nei confronti della realtà) si può incrociare e abbinare bene, a mio avviso, alla concezione adorniana della filosofia come “ontologia della condizione falsa”: come si legge in Dialettica negativa, “un’ontologia della cultura dovrebbe includere ciò in cui la cultura in genere ha fallito”. Penso che si tratti, in entrambi i casi, di indicazioni estremamente stimolanti e ancora proficue ai fini di un confronto aperto con il senso e la funzione della conoscenza e della cultura oggi, e non escludo che uno dei progetti futuri a livello di studio e di pubblicazione possa riguardare proprio il confronto fra due autori come Foucault e Adorno su ragione, storia, libertà e cultura.
Stefano Marino è Professore Associato di Estetica presso l’Università di Bologna. Le sue ricerche vertono principalmente sull’ermeneutica filosofica, la teoria critica, il neopragmatismo, la filosofia della musica e l’estetica della moda. È autore delle monografie Verità e non-verità del popular. Saggio su Adorno, dimensione estetica e critica della società (2021), La filosofia dei Radiohead (con E. Guzzi, 2021), Le verità del non-vero. Tre studi su Adorno, teoria critica ed estetica (2019), Aesthetics, Metaphysics, Language: Essays on Heidegger and Gadamer (2015), Aufklärung in einer Krisenzeit: Ästhetik, Ethik und Metaphysik bei Theodor W. Adorno (2015), La filosofia di Frank Zappa (2014), Gadamer and the Limits of the Modern Techno-scientific Civilization (2011). Ha tradotto i libri di Th. W. Adorno, Variazioni sul jazz (2018), di C. Korsmeyer, Il senso del gusto. Cibo e filosofia (2015) e di H.-G. Gadamer, Ermeneutica, etica, filosofia della storia (2014) e Che cos’è la verità (2012). Ha pubblicato come co-curatore i volumi: The “Aging” of Adorno’s Aesthetic Theory (2021), Pearl Jam and Philosophy (2021), Aesthetics and Affectivity (2021), Romanticism and Popular Music (2021), Kant’s “Critique of Aesthetic Judgment” in the 20th Century (2020), The Culture, Fashion, and Society Notebook 2020 (2020), “Be Cool!” Aesthetic Imperatives and Social Practices (2020), Deconstruction (2020), Adorno and Popular Music (2019), Populismo, femminismo, popular culture (2019), Filosofia del jazz e prassi di libertà (2018), Philosophical Perspectives on Fashion (2016), Theodor W. Adorno: Truth and dialectical experience (2016), Nietzsche nella Rivoluzione Conservatrice (2015), Filosofia e Popular Music (2013), Da quando siamo un colloquio. Percorsi ermeneutici nell’eredità nietzschiana (2011), Domandare con Gadamer (2011) e I sentieri di Zarathustra (2009). È inoltre batterista rock-jazz e autore di due raccolte di poesie, Frammenti di agonia umananimale (2015) e Fratture multiple alle ossa e al cuore (2019).
Giuseppina Capone


 45 uscite in edicola per raccontare con linguaggio semplice e ricche illustrazioni la Bibbia ai piccoli lettori. Una pubblicazione edita da RBA Italia per far conoscere il vecchio e il nuovo testamento attraverso le più belle storie dei libri della Genesi, dell’Esodo, dei Giudici, di Samuele, di Re e da altri libri. Dal nuovo testamento i piccoli lettori potranno seguire il racconto della vita di Gesù.
45 uscite in edicola per raccontare con linguaggio semplice e ricche illustrazioni la Bibbia ai piccoli lettori. Una pubblicazione edita da RBA Italia per far conoscere il vecchio e il nuovo testamento attraverso le più belle storie dei libri della Genesi, dell’Esodo, dei Giudici, di Samuele, di Re e da altri libri. Dal nuovo testamento i piccoli lettori potranno seguire il racconto della vita di Gesù.

 La collana di libri illustrati proposta in edicola da Hachette si compone di 70 uscite con cadenza settimanale e con la mitologia “apre le porte di un mondo di fantasia e di avventure”.
La collana di libri illustrati proposta in edicola da Hachette si compone di 70 uscite con cadenza settimanale e con la mitologia “apre le porte di un mondo di fantasia e di avventure”.



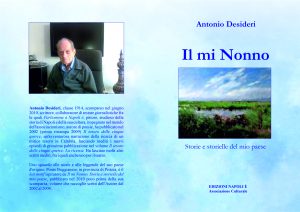 Il volume è stato ripubblicato dall’Associazione Culturale “Napoli è” nel 2021 per ricordare la scomparsa dello scrittore e collaboratore di varie testate giornalistiche e della stessa Associazione, raccoglie gli scritti dell’Autore dal 2002 al 20024.
Il volume è stato ripubblicato dall’Associazione Culturale “Napoli è” nel 2021 per ricordare la scomparsa dello scrittore e collaboratore di varie testate giornalistiche e della stessa Associazione, raccoglie gli scritti dell’Autore dal 2002 al 20024.


