Rudy Salvagnini è uno sceneggiatore di fumetti. Ha scritto centinaia di storie per Topolino, Il Giornalino, Il Messaggero dei Ragazzi, LancioStory e molte altre testate. In campo letterario, sono suoi il romanzo di fantascienza Il vortice dei ricordi (Alcheringa, 2017) e la raccolta di racconti horror Nel buio (Weird Book, 2020). Critico cinematografico, collabora a Segnocinema e a MYmovies. Ha scritto Hal Ashby (Il Castoro Cinema, 1992), Il cinema di Bob Dylan (Le Mani, 2009) e Il cinema dell’eccesso vol. 1 e 2 (Crac, 2015 e 2016). Ha scritto anche e soprattutto il Dizionario dei film horror (Corte del Fontego, 2007 e 2011), di cui è appena uscita la terza edizione (Bloodbuster, 2020). Ne parliamo con l’autore.
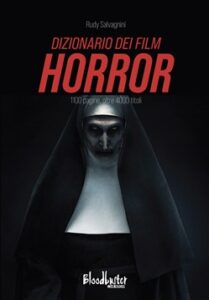
Il sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell’ignoto. Da dove spunta il suo interesse per l’horror?
Quando mi interrogo sulla questione, credo di percepire che ciò che mi ha da subito attirato verso questo genere è l’aspirazione al soprannaturale, che non è un elemento essenziale dell’horror, ma è molto frequente in esso. In un piccolo e modesto film spagnolo, Errementari, a un certo punto un pavido e insicuro sacerdote si trova di fronte a una micidiale creatura demoniaca e, in modo solo apparentemente incongruo, la ringrazia perché con la sua presenza gli ha finalmente dato la certezza che la sua vita non era stata sprecata: se il diavolo esiste, c’è il soprannaturale e anche quello in cui lui, il sacerdote, ha sempre cercato di credere. Quindi, se esiste il Male, è probabile che esista anche il Bene e questo è già qualcosa e l’horror, magari inconsciamente, ce lo rappresenta facendoci nel contempo riflettere sul mistero dell’esistenza. In questo senso è tipica anche la figura dei fantasmi – riflessi di noi stessi, solo più consapevoli – allegoria di qualcosa diverso da noi, ma vicino a noi. Oltre a ciò, che rappresenta il fascino del fantastico, c’è la grande attrattiva che, per me, l’horror ha quale genere metaforico per eccellenza, con la sua capacità di scandagliare la nostra società con una severità e una schiettezza altrove difficili da trovare. L’orrore fa parte della natura umana, l’abisso che ci guarda e che noi guardiamo, la morte che incombe, piacevolezze insomma su cui l’horror ci fa meditare e che a volte invece esorcizza trivializzandole. Alla fine, questo desiderio di spaventare e spaventarsi è sì come un viaggio nel tunnel dell’orrore di un luna park, ma è anche un viaggio dentro noi stessi. E questo mi ha sempre interessato.
L’horror è uno dei generi più fecondi e persistenti della storia del cinema. Qual è il suo linguaggio e come riesce a rispecchiare sempre la contemporaneità?
La forza dell’horror è quella di interpretare sentimenti e paure comuni a tutta l’umanità, sotto ogni latitudine: sa parlare un linguaggio universale compreso dovunque. In ogni parte del mondo c’è una tradizione horror: messicana, spagnola, persino brasiliana. Ci si è accorti solo negli ultimi vent’anni che esiste quella asiatica, ma esiste da un pezzo: capolavori come Jigoku ci ricordano che in Giappone gli horror ci sono da molto. Hong Kong, Indonesia, Filippine, ognuno con i suoi mostri e i suoi vampiri, quelli saltellanti di Hong Kong e i Pontianak, teste volanti con brandelli di intestini, in Malesia. Non esiste un altro genere che si sa coniugare così perfettamente con il comune sentire di ciascun popolo, proprio perché fa riferimento a un folclore radicato e persistente. L’horror non è mai particolarmente di moda perché sostanzialmente lo è sempre.
La storia del cinema dell’orrore di Teo Mora, alcuni volumi di Solfanelli, Monster Show di David J. Skal; Danilo Arona su Craven, Fabrizio Liberti su Carpenter, Daniela Catelli su Friedkin o Gianni Canova su Cronenberg. Per quale ragione, a suo giudizio, la produzione di critica cinematografica del genere horror in Italia non è nemmeno in lontananza equiparabile a quella rinvenibile in altri paesi?
Oltre a quelli citati ci sono molti altri testi sul cinema dell’orrore in italiano – ne hanno scritti Fabio Zanello, Roberto Curti, Gordiano Lupi, Antonio Tentori, Mario Gerosa, Albiero e Cacciatore, per citare solo alcuni nomi tra i tanti – ma è vero che la produzione, in particolare, anglo-americana è decisamente superiore a livello quantitativo. Se ci pensiamo bene però è anche decisamente superiore la produzione di film horror e le due cose sono molto collegate. Negli USA, gli horror hanno una tradizione produttiva solidissima, continuativa ed enorme in quantità per cui esiste un pubblico maggiore anche per la pubblicistica. Da cosa, insomma, nasce cosa.
Quale criterio ha adottato per operare le sue scelte tassonomiche?
Siamo in un campo, quello della critica cinematografica e della conseguente suddivisione del cinema in generi, che solo in parte può dirsi scientifico, per cui le regole di classificazione si sono per forza di cose basate su criteri insieme oggettivi e personali. Ho cercato di darne conto in qualche misura nella Guida alla consultazione contenuta nel Dizionario, ma la questione è di certo complessa e impregnata di soggettività.
Cos’è mutato nei dieci anni intercorsi dall’ultima versione ad oggi?
Come sempre, il cinema horror ha mostrato vitalità invidiabile, rigenerandosi e reinventandosi. Tra le tendenze principali c’è stata senza dubbio quella del found footage – film apparentemente realizzati con filmati “veri” – che ha prodotto una notevole quantità di film spesso premiati dal successo. Ma, esattamente all’opposto, c’è stata la grande crescita dei film prodotti dalla Blumhouse, raffinate rivisitazioni dei capisaldi dell’horror con poco di nuovo, ma molto stile. E ci sono naturalmente state le singole perle provenienti da ogni parte del mondo come il coreano Train to Busan, il giapponese Zombie contro zombie o l’australiano Babadook. Insomma, la consueta vitalità di un genere che non muore mai, come i mostri che spesso lo popolano.
Giuseppina Capone





 Il suo romanzo ha una costruzione “a specchio”. Quanto diverge dal genere codificato dalla tradizione e qual è la tecnica che ha adottato?
Il suo romanzo ha una costruzione “a specchio”. Quanto diverge dal genere codificato dalla tradizione e qual è la tecnica che ha adottato?
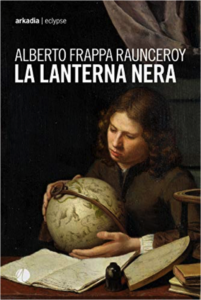 Cos’è la “lanterna nera” e quali furono i suoi effetti?
Cos’è la “lanterna nera” e quali furono i suoi effetti?


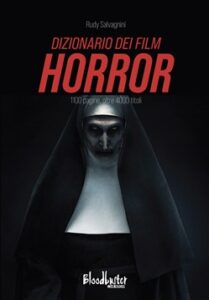

 Si reputa che la intimate partner violence si riveli una strategia per “fare il genere”, e per “fare le maschilità”. La polisemia di accezioni (genere linguistico, biologico e sociale) che la lingua sviluppa dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?
Si reputa che la intimate partner violence si riveli una strategia per “fare il genere”, e per “fare le maschilità”. La polisemia di accezioni (genere linguistico, biologico e sociale) che la lingua sviluppa dimostra quanto la dimensione linguistica emani riecheggiamenti nella maniera in cui si avverte la realtà, si erige l’identità e si calcificano i preconcetti. Reputa che modi di dire, proverbi e battute possano costituire l’anticamera di forme di violenza?
